L’ultimo Caproni (di Daniele Piccini)
Dopo quella di ieri, ecco una nuova lettura di Giorgio Caproni.
(La fotografia in copertina è di Dino Ignani.
Cliccare sull’immagine per la visualizzazione completa)
L’ultimo Caproni: la caccia, l’ónoma, Dio
di Daniele Piccini
La prima volta che Giorgio Caproni mise al centro di una sua poesia il tema della caccia nell’accezione allusiva e subito intensamente metafisica che sarà del Franco cacciatore (Garzanti, Milano 1982) fu in un testo del maggio 1961, Il fischio, apparso sulle pagine della rivista “Critica d’oggi” (4, gennaio 1962) e infine accolto nel volume Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee (Garzanti, Milano 1965). È qui anticipato il fruttuoso campo metaforico che il libro del 1982 passerà poi in eredità, come metafora centrale, spunto narrativo trainante dell’intera raccolta, al successivo Il Conte di Kevenhüller (Garzanti, Milano 1986).
Tutte le possibili implicazioni di questo tema, in prima sede narrative, ma immediatamente identificabili con ragioni e suggestioni d’ordine conoscitivo, quel testo già le lascia presagire, le accoglie nel proprio corpo pur senza tutte svolgerle. Certo vi domina, per così dire, una certa evidenza allegorica, un’insistenza sul risvolto scenico e teatrale della situazione che subito ce la segnala come simbolica, astratta (al pari di quel che accade nel più celebre Congedo del viaggiatore cerimonioso che presta il titolo all’intera raccolta), mentre in seguito il motivo della caccia, della battuta nell’intrico di campi e boschi, della ricerca affannosa della preda ottiene nel più stringato, concentrato dettato poetico dell’ultimo Caproni un’indistinguibile unità di situazione reale e insieme di angosciosa proiezione di uno stato della mente. L’ultimo tempo di Caproni si segnala infatti per un’operazione di estrema scarnificazione che non è deperimento del tessuto testuale, ma incremento di concentrazione, strenua attenzione rivolta, quasi ossessivamente, ad un problema, o meglio a un ventaglio di decisive questioni, per cui il paesaggio della poesia e la sua orditura linguistica diventano di una ossea essenzialità, abbandonando e superando da una parte la più facile cantabilità precedente (nelle cose più alte di straordinaria bellezza) e dall’altra una certa duplicità di piani del discorso, con la presenza di figure (nella fase immediatamente precedente Il franco cacciatore) più allegoriche che immediatamente impastate di verità e consistenza reale. Ci pare infatti netto il guadagno in verità ed efficacia delle situazioni e delle figure, pur metafisiche, del Franco cacciatore rispetto alla media di quelle del precedente Muro della terra (Garzanti, Milano 1975), dove a volte prevale una certa cerebralità nell’invenzione delle situazioni narrative che le fa sentire come insufficienti a se stesse e un po’ astruse (si possono vedere per questo aspetto poesie come Il cercatore, Testo della confessione, Parole (dopo l’esodo) dell’ultimo della Moglia, Andantino, testi già incentrati sui temi decisivi del più tardo Caproni, quali, fra l’altro, l’uccisione di Dio e lo sdoppiamento di sé, ma ancora non del tutto risolti in figure poetiche di per sé evidenti) [1]. Una cantabilità popolare e semplice, ma insieme di grande capacità evocativa e tenuta formale, connota tutto il primo Caproni e si complica e arricchisce soprattutto fra i Sonetti dell’anniversario (in Cronistoria, Vallecchi, Firenze 1943) e Il passaggio d’Enea (ibid. 1956) [2] di una “disperata tensione metrica”, come dice lo stesso Caproni nella Nota alla ristampa einaudiana del Terzo libro. Tale estrema tensione detta forse i più bei sonetti del nostro Novecento (quelli appunto dell’anniversario in Cronistoria) ma in parte conferisce ai testi del Passaggio d’Enea un’aura di clausura e una dizione ‘arcaizzante’ che il successivo Il seme del piangere (Garzanti, Milano 1965), mirabile agiografia della madre del poeta Annina Picchi (stando alla sezione principale dei Versi livornesi), in buona misura respinge per tornare, sia pure in una geniale e irripetibile rivitalizzazione delle forme della ballata cavalcantiana [3], alla più lieve, aperta, toccante liricità della prima maniera del poeta. Mezzo tecnico imprescindibile non solo di questa fase cantabile e ‘aperta’, ma dell’intera scrittura caproniana, è la rima. Ebbene la rima conosce nelle ultime raccolte una risignificazione nella modalità compositiva del poeta, acquistando una nuova pregnanza di senso. Certo essa non solo formale strumento di musaica armonizzazione era nel primo Caproni, servendo anche, come la calcina a cementare i mattoni, ad innalzare l’edificio del testo (si pensi appunto alla forma metrica chiusa del sonetto o a quel singolarissimo hapax metrico che è la Litania [4]), ma prevalentemente eufonica era ancora, o comunque non così decisamente assunta a strumento primo della veicolazione del senso testuale come accade nelle ultime prove, a partire almeno dal Muro della terra. In esse la rima, battuta e ribattuta, fuori d’ogni anche lontana ripresa di strutture metriche tradizionali (se non ad un livello di scarnificazione e svuotamento estremi), utilizzata in testi a volte brevissimi, sempre comunque privati di ogni orpello anche musicale e ridotti all’essenziale, ricorrendo spesso in posizione denunciatamente ravvicinata e in contesti sintattici semplificati e per lo più fortemente segmentati (con frasette giustapposte ed isolate da segni di punteggiatura forti), è una vera e propria sonda, una rete a cui restano impigliate, nell’indefinito mare semantico delle parole, quelle che per via di tale strumento non possono non richiamarsi fra loro. La rima (specie nelle poesie più brevi e ‘fulminanti’) costruisce il testo, ne indica la direzione, ne permette, per necessaria aggregazione mai prioritariamente consapevole, il disporsi. È Caproni che in Res amissa intitola un testo minimo (esemplificativo di quanto qui si dice) proprio Fatalità della rima [5]:
La terra.
La guerra.
La sorte.
La morte.
Ebbene quel vero e proprio corto circuito semantico che è, in Caproni, la rima più volte ripropone il parossistico confronto che la lingua italiana ha nel suo patrimonio cromosomico (intraducibilità e necessarietà della poesia) fra io e Dio; fino al versicolo lancinante che chiude Res amissa [6] e con quella l’intero corpus scrittorio del poeta, Anch’io: “Uno dei tanti, anch’io. / Un albero fulminato / dalla fuga di Dio”.
Con ciò siamo ad uno dei punti nevralgici del nostro discorso. Dal Franco cacciatore (già dal Muro della terra, ma non ancora con la stessa radicale efficacia) la poesia di Caproni pur senza rinnegare i temi precedenti (Raboni in un celeberrimo luogo critico sul Nostro [7] ne ha individuati tre centrali, quelli della città, della madre – in sostanza limitato al Seme del piangere – del viaggio) e non senza rinvenirne di nuovi, si focalizza con straordinaria intensità intorno al tema abissale e definitivo della lotta con Dio. Del resto lo stesso Raboni nell’intervento citato si sofferma su questo tema (“dell’inesistenza e necessità di Dio, dell’impossibilità di scovare il “Deus absconditus”, ma anche di cancellarne il buco, il vuoto, il nome”). La poesia stessa, intera, è continuamente intesa come il ‘luogo’ dove lampeggia la possibilità della presenza di Dio, sempre negata, ma sempre ogni volta ri-suscitata come l’unica vera questione, come l’ultimo, definitivo nodo che la parola poetica implica. Dio non esiste – afferma a più riprese il poeta. Ma è la questione della sua esistenza, della sua possibilità di esistere che ingombra in chiave ora dissacratoria, ora dolente, sempre in maniera decisiva e bruciante la voce del poeta. È celebre il primo Inserto prosastico del Franco cacciatore che parla della solitudine senza Dio. Essa, adito a tutte le libertà possibili, comprende anche “quella (la serpe che si morde la coda) di credere in Dio, pur sapendo – definitivamente – che Dio non c’è e non esiste”. Questo passo, che appartiene forse a quelli più cerebrali del poeta, sembra nonostante tutto esemplificativo di una sorta di ‘schizofrenia’ che si manifesta nella sua tarda scrittura poetica. Essa è impegnata in una sorta di fuoco incrociato contro (cioè verso) quel Dio che ogni volta si ripete non esistere. Infatti “- Zitto. Dio esiste soltanto / nell’attimo in cui lo uccidi” risponde “imbracciando il fucile” il cacciatore al guardacaccia sfiduciato nel terzo testo del Franco cacciatore. L’uccisione, vale a dire la negazione di Dio, è l’estremo gesto di ricerca, è la tensione verso un punto, una questione riconosciuta la più degna della domanda (e della disperazione, eventualmente) dell’uomo [8].
Il senso di una domanda inclusa nella stessa parola poetica è lo scatto decisivo apportato dal successivo Conte di Kevenhüller (ma già anticipato dal citato Il fischio: “che vale temere il nemico / fuori, quand’è già dentro?”), costruito su un canovaccio narrativo di grande suggestione: la “generale Caccia” bandita dal Conte per eliminare la “feroce Bestia” imperversante per la campagna (di fine Settecento) del Milanese. La Bestia può essere metafora del Male o più in generale dell’ignoto che preme sull’uomo e lo tormenta, spostando continuamente il suo sguardo verso un altrove senza dargli certezza e consistenza (non è questo il fondo del tema del viaggio in Caproni?). La battuta di caccia contro la Bestia è, come il “colpo fulminante / del franco cacciatore”, il momento di frenesia e di “straziata allegria” perché in quell’atto l’uomo impegna la questione fondamentale della sua esistenza. Ma soltanto il poeta sa che c’è davvero una “serpe che si morde la coda”: la Bestia, Dio, la caccia stanno dentro la sua parola, ne sono la trama ultima e necessaria. Infatti in Io solo si dice: «[…] La Bestia che ti vivifica e uccide… // …… // Io solo, con un nodo in gola, / sapevo. È dietro la parola”. E alla fine di Lei: «Soltanto e inequivocabilmente / lei, la Bestia / (l’ónoma) che niente arresta».
L’ónoma (il nome, dunque la parola), a cui poi è dedicato il testo successivo, è il ‘luogo’ della Bestia. Il libro del 1986 quindi (a cui Res amissa non aggiunge che forza e precisazione, semplicemente riguardando questa stessa vicenda di ricerca dall’ottica della perdita e della mancanza) esprime la fede che sia celato nelle parole un senso, che vi sia una necessità nel loro uso, nel richiamo di una all’altra verso una riposta zona ‘sacra’, raggelante luogo della caccia e della quaestio. La caccia è in fondo un aggirarsi nel corpo smisurato del verbo, è l’agghiacciante percezione di avere lì, in quello strumento, il Nemico, la Belva, il Bersaglio cercato e temuto ad un tempo, la Res amissa. Infine: la parola è un’alterità, un corpo, una ‘regione’ altra, in cui il poeta si muove, messo di fronte a questo spossessamento, di fronte alla consapevolezza di essere entrato nella terra ‘infestata’ dalla Belva. Così si giustificano anche le frequenti immagini della dogana, del confine che la serrata indagine in versi dell’ultimo Caproni continuamente fa balenare. I luoghi, mentali ed estremi, evocati da questa strenua tensione del verbo sono infatti “i luoghi / non giurisdizionali” (i luoghi sottratti alla giurisdizione della ragione) cui giungono, “le ossa a pezzi”, “[…] ciascuno / avvolto nella nube vuota / dei suoi pensieri”, i sospesi cercatori de L’ultimo borgo [9]. La parola reca con sé un resto di radicale alterità: debole e fragile nel confronto con la creazione (si veda in Res amissa l’epigrammatica Concessione: “Buttate pure via / ogni opera in versi o in prosa. / Nessuno è mai riuscito a dire / cos’è, nella sua essenza, una rosa”) tanto da tradirla e vanificarla (da Le parole nel Franco cacciatore: “Le parole. Già. / Dissolvono l’oggetto. / […]”), conserva tuttavia una zona di sfuggenza alla volontà egotica, al controllo e al progetto dello scrivente, conserva la traccia di un necessario moto all’infinito che la colma smisuratamente di valore e la rende ‘paurosa’. Sembrano rappresentare una tangibile dimostrazione testuale di questo discorso (di questo insorgere nella parola di una alterità irriducibile) i Versicoli del controcaproni, una prima tranche dei quali è pubblicata, il poeta in vita, nella raccolta Tutte le poesie (Garzanti, Milano 1983) e una seconda, postuma, come ultima sezione di Res amissa (ibid. 1991), i quali, dice fra l’altro testualmente Caproni nella nota che li accompagna, “si sono scritti da soli, contro la mia volontà, crescendo di numero ogni giorno”. Non si può non osservare come questi versicoli, letteralmente nati contro la volontà dello scrivente, sovrabbondino di quel tema del fronteggiamento fra Dio e l’io poetante di cui si diceva, esprimendolo in modi epigrammaticamente memorabili [10]. La parola, dunque, come capace di raggelare il poeta che vi percepisce la voce di un altro, la traccia della cosa perduta. La parola si sottrae ad ogni progetto di autosufficienza e intransitività, denuda, espone colui che se ne serve – cercando di esaurirla – alla vertigine della domanda sul senso; comporta la questione di Dio, nella lotta col quale sembra infine consistere il destino ultimo dell’io. Potrebbe spiegarsi a partire da questa osservazione quella continua ambiguità nelle raccolte tarde del poeta fra la figura dell’uccisore e quella dell’ucciso (così soprattutto nel Franco cacciatore e nel Conte di Kevenhüller): sembra dircelo l’ultimo dei versicoli pubblicati nella raccolta Tutte le poesie, intitolato Di conseguenza, o: Proverbio dell’egoista: “Morto io, / morto Dio”. Al solo ammettere una qualche reciprocità di quel rapporto, come in certa misura suggerisce nel Franco cacciatore la sezione Reversibilità e in essa soprattutto la poesia Rivalsa, si potrebbe forse spiegare perché spesso il fucile della caccia caproniana finisca per colpire l’ombra di chi spara.
La caccia perciò, metafora centrale almeno delle ultime due raccolte pubblicate in vita dall’autore, consiste, come suggeriscono diversi testi delle stesse (dal Franco cacciatore: L’occasione, Preda; dal Conte di Kevenhüller: Strambotto, Consolazione di Max, L’Abate) nel mirare in alto, nello sparare contro il vuoto del cielo, verso Dio. La parola sembra acquistare agli occhi del poeta la valenza di mezzo il più serio e il più radicalmente decisivo (persistendo la sua limitazione di mezzo fragile e mancante di fronte alla pienezza del creato) proprio in rapporto a questa sua altissima vocazione, anche contro la volontà razionale dello scrivente, quasi con moto proprio, verso la caccia e in ultimo la nostalgia di Dio. Perciò non si sottolineerà mai abbastanza, a parer nostro, l’inopportunità della definizione di poesia dell’ateologia, peraltro suggerita più o meno seriamente dallo stesso poeta [11], riferita alla scrittura di Caproni. Certo è dichiarato il rifiuto di ogni credo positivo (basterebbe l’esplicito Mancato acquisto in Res amissa), ma è raro imbattersi in una poesia così corporalmente coinvolta, in lotta col divino com’è quella dell’ultimo Caproni [12]. Nemmeno di teologia negativa si può in senso proprio (cioè tecnico-filosofico) parlare; sarebbe invece tutt’altro che fuorviante riconoscere in questo scorcio dell’opera poetica caproniana una poesia teologica, nel senso etimologico di una poesia che ha il suo centro nel discorso – che diventa narrazione e vicenda – su Dio o, volendo accogliere un ironico ma tagliente suggerimento dello stesso poeta [13], riconoscervi una poesia ‘patoteologica’, nel senso di una scrittura che accoglie nel proprio corpo come un inestirpabile e irrinunciabile punctum dolens la questione di Dio.
(da Atelier n. 11)
[1] Opposto (a favore cioè del Muro della terra) il giudizio di valore sulle due raccolte espresso da P. V. MENGALDO, Per la poesia di Giorgio Caproni, introduzione a G. CAPRONI, L’opera in versi, ed. critica a c. di L. ZULIANI, Mondadori, Milano 1998.
[2] Cioè la parte nuova (ampliamento delle precedenti Stanze della funicolare, De Luca, Roma 1952) aggiunta alla raccolta, intitolata complessivamente Il passaggio d’Enea, di quanto fino ad allora pubblicato dal poeta, parte poi ristampata, con l’espunzione di alcuni testi e l’inserimento di altri, in Il “Terzo libro” e altre cose, Einaudi, Torino 1968.
[3] A proposito dell’intertesto cavalcantiano, interpretato da CAPRONI in modi risolutamente novecenteschi, ci permettiamo di rimandare alla nostra lettura di Ultima preghiera: D. PICCINI, Caproni e la gioia sognata dell’antenascita, «clanDestino», 3/1997, pp. 5-8
[4] Cfr. l’esame analitico di A. GIRARDI, Un hapax metrico: “ Litania”, in Genova a Giorgio Caproni, a c. di G. DEVOTO e S. VERDINO, Edizioni San Marco dei Giustiniani, Genova 1982, pp. 105-119.
[5] Le due coppie di parole-rima allegate da CAPRONI come ‘fatali’ sono in effetti comuni ed hanno (specie la prima) numerose occorrenze nella tradizione poetica italiana. Ma forse il testo da cui ha tratto spunto il poeta può essere ravvisato in Rerum vulgarium fragmenta, CCC, sonetto dove la prima coppia usata da CAPRONI ricorre nella prima quartina e la seconda fra le due terzine.
[6] Così come compaginata nell’edizione in volume del 1991, mentre la recente edizione critica di LUCA ZULIANI apporta delle modificazioni nell’ordine e rimuove dalla chiusa assoluta di raccolta il testo in questione.
[7] G. RABONI, Caproni al limite della salita, “Paragone”, 334 (dicembre 1977), pp. 112-116, poi con rielaborazioni in ID., Introduzione a G. CAPRONI, L’ultimo borgo. Poesie (1932-1978), Rizzoli, Milano 1978, pp. 5-13, infine, con ulteriori aggiustamenti, in G. Caproni, Tutte le poesie, Garzanti, Milano 1983, pp. 617-622 e nella successiva raccolta complessiva – escluso il postumo Res amissa – dell’intera poesia caproniana, G. CAPRONI, Poesie 1932-1986, ibid. 1989, pp. 793-798.
[8] Non ci sembra infatti esaustivo ricondurre semplicemente la questione dell’invocazione-negazione di Dio, come molti interpreti fanno, ad una più generale tendenza del CAPRONI ultimo alla contradditorietà, alla sistematica coesistenza e reversibilità dei termini opposti.
[9] Apparso, prima di essere accolto nel Franco cacciatore, nell’antologia già citata, a cui il testo dà il titolo, curata da RABONI.
[10] Del tutto differente dall’interpretazione qui proposta dei versicoli è quella fornita da G. AGAMBEN, Disappropriata maniera, Prefazione a G. CAPRONI, Res amissa (in part. p. 25: “ I versicoli sono le scorie – il troppo proprio – che si scheggia dall’implacabile lavoro di disappropriazione che caratterizza la maniera suprema di Caproni ”), riflettendo un’impostazione generale sul problema critico (e gnoseologico) costituito dall’ultima fase della poesia di CAPRONI affatto divergente da quella qui sostenuta.
[11] Cfr. il versicolo, accolto in Tutte le poesie, Metereologia.
[12] Su questo tema si intrattenne con partecipe riflessione, recensendo Il franco cacciatore, G. TESTORI, Quel “lui” che resta in fondo alla poesia, “Corriere della Sera”, 4 giugno 1982, sia pure, ci pare, spingendosi troppo oltre nella lettura in chiave affermativa della negazione caproniana (o insomma della sua straziata ricerca attraverso l’assurdo della preghiera stravolta e dell’uccisione di Dio). Più equilibrata la lettura sempre dedicata al motivo della presenza di Dio nell’ultimo CAPRONI di D. M. TUROLDO, Un “mendicante di Dio” che nega e afferma insieme, “Jesus”, 8 (febbraio 1986), II, pp. 20-22. Intorno alla possibilità di vedere nella più recente poesia di Caproni (arrivando però solo fino al Muro della terra) un continuato discorso teologico (più o meno ‘negativo’, ossimorico, antifrastico) si è soffermato anche G. Barberi Squarotti, Poesia e teologia: l’ultimo Caproni, in Genova a Giorgio Caproni, pp. 131-146. Sullo stesso tema si vedano anche, fra i molti che vi hanno fatto riferimento, G. CALCAGNO, Il ‘deus absconditus’ di Caproni e E. GIOANOLA, Dio per Caproni? La rima con io, entrambi in Per Giorgio Caproni, a c. di G. DEVOTO e S. VERDINO, Edizioni San Marco dei Giustiniani, Genova 1997, rispettivamente pp. 47-54 e 89-103.
[13] Cfr. il versicolo ‘intitolato’ Senza titolo, II in Tutte le poesie.
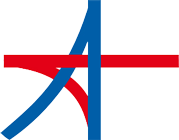












grazie, molto utile (per un confronto con Testori, su cui sto lavorando)