La generazione entrante
Se, come ricorda l’articolo pubblicato ieri, gli autori nati negli anni Ottanta sembravano tardare, a differenza dei poeti nati negli anni Settanta, a mostrarsi all’orizzonte, la rivista Atelier si è impegnata per creare delle condizioni favorevoli, con una pubblicazione che era stata recensita sulla rivista da Elisa Vignali
La generazione entrante. Poeti nati negli Anni Ottanta, a cura di Matteo Fantuzzi, Borgomanero, Ladolfi Editore 2011
di Elisa Vignali
Ponendosi in sostanziale linea di continuità con l’iniziativa promossa da Giuliano Ladolfi nel 1999 con l’Opera comune. Antologia di poeti nati negli Anni Settanta, sempre per «Atelier», il volume La generazione entrante. Poeti nati negli anni Ottanta, a cura di Matteo Fantuzzi, a sua volta poeta ed editor, si propone di “mappare” le esperienze poetiche più sicure e riconoscibili tra gli autori che oggi abbiano vent’anni. Qualche dubbio è lecito muovere proprio sul ricorso al criterio anagrafico, osservato un po’ rigidamente, per la selezione degli autori, quando un allargamento del campo avrebbe magari attivato connessioni più proficue, consentendo di verificare l’effettiva presenza di certe linee vitali (per esempio, la vivacità della poesia neodialettale o la ricezione di determinate tradizioni, anche straniere). Senza contare che proprio in virtù di un simile approccio rimangono esclusi autori nati a cavallo tra i due decenni, ma afferenti per indole e temperamento forse più agli Anni Ottanta che al decennio precedente.
Anche se motivato da criteri di gusto individuale e da ragioni editoriali, appare tuttavia un poco limitato anche il numero delle voci campionate, che registra qualche assenza o che nel complesso appare ristretto rispetto all’orizzonte di possibili altre inclusioni. Nondimeno il volume mantiene una sua validità di fondo nel documentare una realtà per molti versi sommersa, una produzione in versi sovente più affidata alla circolazione in rete che alla carta stampata, consentendo così di misurarsi con un pubblico di lettori che, se nel caso della poesia non può mai dirsi davvero largo e attento, tanto più necessità di un diretto confronto con la parola del testo, fosse anche precaria e in via di necessaria definizione come nel caso di questi giovani autori. Ma non è tanto ora sul criterio generazionale o anagrafico che si vuole qui soffermare la propria attenzione, oscurando la qualità, il quid specifico degli autori selezionati. Su almeno uno degli elementi rilevati da Fantuzzi nella sua introduzione si può, infatti, quasi generalmente concordare: «E proprio dalle opere dobbiamo ripartire se vogliamo risuscitare lo stato della poesia italiana contemporanea, l’unico antidoto […] sono i testi». E sono poi anche altri gli elementi evidenziati dal curatore tali da configurare quest’antologia, al di là di certi limiti in parte inevitabili, come uno strumento di qualche utilità per il lettore che volesse accostarsi ad alcuni dei poeti d’oggi più interessanti: un ritrovato «senso dell’urgenza» del dire, l’intenzione di una «poesia sociale (piuttosto che civile)» che appunto rinsaldi il rapporto un po’ sfilacciato tra letteratura e società (un’esigenza tra l’altro viva anche in altri campi, dalle riviste letterarie a certe piccole e medie case editrici), una differenziazione anzitutto geografica, specchio di una «frammentazione di percorsi che non indebolisce, piuttosto rende possibile una lettura condivisa delle pulsioni che rendono vivo il fare poetico», e infine la ricerca, tutt’altro che pacificata, di una propria identità, come a dire di un proprio stile, non ancora del tutto affinato ma dai tratti già riconoscibili e, nei casi migliori, persino maturi. E ancora, tra gli elementi non rilevati nell’introduzione: la configurazione del rapporto maschile/femminile in termini rinnovati e meno stereotipati, per la disponibilità della voce maschile ad assumere entro di sé quella femminile e viceversa, in accordo con un’identità fluida; e ancora l’allargamento di orizzonti geografici e interculturali, con significative aperture a tradizioni letterarie e lingue sovranazionali, tali da produrre interessanti stratificazioni anche a livello linguistico.
Circa la «necessità sempre più pressante di farsi comprendere, di utilizzare figure, immagini, espressioni, dialoghi vicini al linguaggio comune», procederei invece con maggiore cautela, perché se è vero che la qualità di una scrittura poetica consiste anzitutto, per usare una metafora del grande poeta irlandese Seamus Heaney, in un’operazione di scavo che tramite il pensiero consente di tradurre una percezione interiore in una trama di parole, un eccessivo scadimento del linguaggio a livello della comunicazione quotidiana rischia di abbassarne notevolmente il potenziale espressivo. Anche se poi, in verità, non sono pochi gli autori inseriti nell’antologia, ancorché all’inizio del loro percorso, a mostrare di avere recepito la lezione anche formale dei nostri maggiori poeti, maestri di stile prima ancora che abili costruttori di immagini, non limitandosi a riprodurne stancamente i modi, ma riassorbendone gli echi entro la propria officina verbale. Allo stesso modo, non sempre l’oltrepassamento di un Novecento “sperimentale”, di cui si vorrebbe trovare conferma nel volume, si è prodotto o è bene si produca, almeno se s’intende il termine “sperimentale” in accezione più produttiva di quella che vorrebbe confinarlo negli angusti confini dello sperimentalismo, e non lo s’intenda invece, come forse si dovrebbe, come inesausta capacità di sprigionare sempre nuove risorse vitali dalla lingua poetica. Si pensi a un poeta come Porta, peraltro assunto a punto di riferimento da più d’uno di questi poeti nati negli anni Ottanta, capace di superare le secche del neoavanguardismo per riconquistarsi uno spazio di autenticità, verbale, oltre che esperienziale. Certo l’aggancio al reale, (con il suo portato anche traumatico) nelle sue varie declinazioni, il «rifiuto di una lirica concepita come intuizione e libera effusione della soggettività o come espressione poetica di un’individualità assoluta», sottolineati da Giuliano Ladolfi nella lucida e a un tempo appassionata postfazione che chiude il volume, sono il dato che più accomuna gli autori antologizzati, rendendo in fondo ragione di una loro appartenenza a una medesima sensibilità, se non comunità. Se è vero, poi, che a fronte di un futuro fattosi sempre più incerto, non più veicolo di speranza, ma «fonte di apprensione», la generazione dei anni Ottanta ha maturato un senso di smarrimento profondo, di cui è emblematica, in molti testi selezionati, la costante della figura paterna, spesso assente o problematica, è pur vero però che si assiste a un tentativo ininterrotto di dialogare con i padri della tradizione, entro un rapporto più mobile e dunque in parte più libero, senza pretese di autoinvestiture o l’assunzione posticcia di pose compiaciute.
Proviamo allora a predisporci all’ascolto di queste “nuove” voci del panorama poetico italiano, liberi per una volta da pregiudizi e dall’ingombro di categorie interpretative precostituite, lasciandoci guidare nel percorso dalle note di critici e studiosi che nel firmare l’introduzione a ogni singolo autore antologizzato contribuiscono in qualche misura a riannodare i fili con una storia più consapevole e matura. Si avrà allora anzitutto la sensazione, magari un po’ ingenua ma pur sempre stimolante, di trovarsi di fronte a una sorta di cantiere aperto, di laboratorio in atto, secondo un principio del fare poesia che segue non astratte regole esterne, ma una ritmica e una metrica anche interiori. Per ognuna di queste voci non sarebbe improprio ricorrere all’immagine sereniana assai efficace della poesia come «stella variabile»: la raccolta di Vittorio Sereni (una delle presenze sicuramente più certificabili nelle pagine di quest’antologia, insieme ad altri poeti della quarta generazione) usciva proprio nel 1981 e fin dal titolo intendeva riferirsi alla poesia e al suo rapporto col mondo, alla sua condizione, appunto, di stella non fissa, non più in grado di fornire certezze o dispensare verità assolute, e invocata senza che possa promettere nessuna salvezza, nessun risarcimento del vuoto personale e storico. Essere nell’oggi significa appartenere al male: «Oggi si è — e si è comunque male / parte del male tu stesso tornino o no sole e prato coperti». Nei versi di Sereni, animati da un senso tragico dell’esistenza, eppure ancora resistente di fronte alla forze regressive operate dalla Storia, la violenza e i segni del massacro si nascondono in ogni gesto; la vita quotidiana e ripetitiva del lavoro non fa trasparire alcuna ipotesi di comunicazione umana, ma solo un logoramento che penetra nelle persone e nei luoghi, privandoli di forza vitale. Tra insicurezze e senso lacerante della precarietà, si sperimentano così limiti e insufficienze della condizione umana, mentre il passaggio del tempo rivela il suo fondo amaro nell’immagine di un «gran catino vuoto» che chiede ora di essere riempito con nuove figure di speranza.
Si parte col compatto manipolo di testi di Dina Basso, che ha esordito appena ventenne con la promettente raccolta Uccalamma (Le Voci della Luna, 2010), in cui l’impasto neodialettale dell’idioma naturale, quello catanese, si piega alla narrazione, spesso in chiave autoironica e già dal piglio sicuro, di accadimenti quotidiani, di esperienze concrete, filtrate da una memoria capace di rimandare tanto a un preciso senso del luogo quanto a un ricco repertorio culturale. Ed è proprio questa naturalità del dire, legata a una concreta «lingua del fare» — come nota nella sua persuasiva introduzione Manuel Cohen —, a una trama di gesti e di parole, il tratto forse più preciso in cui si può far consistere il verso tutto materico di quest’autrice, fisico e mentale insieme.
A seguire, la voce di Marco Bini, nella cui raccolta d’esordio Conoscenza del vento (Ladolfi Editore, 2010), la costante tematica dello smarrimento generazionale è resa mediante un’equilibrata oscillazione di linguaggio colto e linguaggio quotidiano, tra intonazione lirica e cadenze del parlato, nel quadro di una dialettica io / noi che finisce per intrecciare i fili della storia individuale con quelli della storia collettiva. Ed ecco tornare di nuovo, in uno dei versi selezionati, l’immagine astrologica di Sereni, anche se declinata in altra forma: «Solo che non si ferma là davanti / come una supernova ciò che accade / ma più simile a una cometa ostenta / alle spalle una storia”, perché “il futuro certo non è lì che aspetta». Il senso della scrittura, per questo giovane autore, andrà dunque rintracciato nella ricerca inesausta di un orizzonte in cui consistere, di una misura capace di garantire una giusta prossemica, nel tentativo di mappare il reale, ridisegnandone i confini: «Averla questa forza di accorciare / le distanze, indicare gli orizzonti, / nuovamente raccogliere le facce / disparate in un’unica medaglia». E ciò varrà sia nella vita che negli spazi della poesia, dove stile e ritmo spesso sono tutto. Anche il percorso compiuto da Carlo Carabba nei suoi Canti dell’abbandono (Mondadori, 2011) è mosso da un’analoga volontà di ricerca, non necessariamente finalizzata al raggiungimento di una meta, se è vero, come si legge nell’introduzione firmata da Roberto Carnero, che «il miraggio della felicità non consiste nell’arrivare al traguardo ma nel non arrivare, “consumando” esperienze sempre nuove in luoghi, sensazioni, incontri, illuminazioni interiori», secondo una dinamica incessante di fughe e ritorni, partenze e abbandoni. Solo così forse è possibile ritrovare il rapporto perduto con la memoria dei nostri padri, metaforici o reali, rinnovandone lo sguardo nel presente: «Da qui sono partito / qui dove non arrivo», recita un verso in tal senso emblematico tratto dalla raccolta Gli anni della pioggia (PeQuod, 2008).
E ancora troviamo la dimensione itinerante di un homo viator, il cui peregrinare assume la forma di un cercare senza sosta, nei versi di Giuseppe Carracchia il quale, nei passi estratti dalla silloge La virtù del chiodo (L’arca felice, 2011) esplora il reale con intento anzitutto conoscitivo, per misurarne distanze e traiettorie: «Il piede che calza la terra è centro / profondo, e ovunque si sposta dentro / universo tracciato a ogni passo / baricentro del mondo e compasso».
La poesia di Tommaso Di Dio, autore della plaquette Favole (Transeuropa, 2009), propone seppure con accenti del tutto personali alcuni motivi comuni a molti di questi poeti: la dimensione del poeta viandante, da cui deriva un senso profondo di precarietà e di incertezza del futuro, tra paura e attesa per un avvenire dai contorni oscuri, la dialettica tra mente e materia, fra tradizione e apertura al nuovo, secondo una dinamica in questo caso mediata dall’esempio fondativo di Antonio Porta, rappresentante di una lirica «della memoria» e della «carne», come annota efficacemente Stefano Raimondi nella sua introduzione. Il progetto poetico di Tommaso Di Dio appare già delineato nei suoi tratti fondamentali ed è capace in molti casi si produrre buoni esiti, come nella sequenza poematica seguente, tra le più sicure dell’intera raccolta: «Ti voglio credere vera e impossibile/fuga sotto il ventre dell’ariete. La pietra che chiude. / La forza del gigante. Chiudi la fatica degli occhi e abbassa / l’arma dello sguardo; lascia tu aperto il passaggio». Di Francesco Iannone, autore della plaquette Poesie della fame e della sete (Ladolfi, 2011) andrà rilevata, come annota intelligentemente Massimo Morasso, la «ricerca di uno spazio condiviso», che convive con la percezione di una «coscienza ferita». La poesia è capace di produrre senso anche tra i tagli e le slabbrature del reale, nel segno di un realismo riportato a ragioni quasi “elementari”, laddove tra i primari impulsi della fame e della sete si misura anche il potere di sopravvivenza della parola: «La resistenza al nulla è una lotta / che lascia ferite e tagli / è un labbro squarciato da un pugno / è un figlio espulso da un utero contuso».
Nella sua partecipe introduzione Antonella Anedda coglie bene i tratti distintivi della poesia di Domenico Ingenito, poesia dalle tante e diverse “grammatiche” possibili: quella del corpo, anzitutto, per l’oscillazione costante di polo maschile e polo femminile, non rigidamente separati ma dialetticamente cooperanti nel processo conoscitivo; il dialogo con la tradizione, qui più che mai intesa anche come traduzione in atto di «linguaggi distanti», tra italiano, persiano e portoghese. E infine la grammatica, per così dire, dell’immaginazione, capace, come accade nell’ultima poesia riportata, di far parlare due autrici separate da due secoli e da quattromila kilometri. Come nel caso di altri poeti qui antologizzati, la poesia vale come strumento per accorciare le distanze, mantenendo aperto il dialogo tra entità lontane nello spazio e nel tempo. La poesia di Franca Mancinelli, che ha già al suo attivo una raccolta, Mala Kruna, uscita da Manni nel 2007, si connota per la capacità di tradurre il senso di precarietà comune, del resto, a un’intera generazione, in interrogazione universale sul senso dello stare al mondo, con ciò rinsaldando le ragioni dell’io con quelle del noi, mediante un linguaggio poetico che dietro la scorza lirica dei versi nasconde le ferite del reale, «in un codice di nervi e sangue, di corpo e mente interiore», per usare le parole del sottile prefatore Gualtiero De Santi. Come avviene in questi versi: «Ora l’infante potrà camminare / con l’equilibrio che porta le braccia / a sollevarsi inermi dalla terra. / È un giorno strabico, e le persone / s’affacciano sul proprio sangue fermo / chiedendo dove sbuca la corrente / che spinge rossa e perfora gli occhi».
La poesia di Lorenzo Mari, presente con un campione da Minuta di silenzio (L’arcolaio, 2009), è pronta a cogliere scarti e zone liminari del reale, con affinata sensibilità percettiva e una sottesa intenzione ironica, offrendo altre emblematiche immagini del senso di sospensione e incertezza esistenziali. Ne è significativo esempio la figura «dell’uomo che cadeva» al centro di una delle sequenze più riuscite dell’intera raccolta: «Di tanti posti, in riva al mare / è dove conta meno il minuto / di silenzio, stretto tra onda / e risacca, accanto alla figura / fetale, a ossa rotte, dell’uomo / che cadeva. Scrivere sulla sabbia / è gesto romantico, meglio le glosse: / tatuate dal sole con certezza, / e più direttamente, sulla minuta / di silenzio». Ed è tutta da condividere la nota iniziale di Andrea Gibellini che di questi versi coglie «lo stigma irrevocabile della parola poetica detta in sincerità prima della tecnica e di un sentimento stilistico». I versi di Davide Nota, tratti dalle tre raccolte finora pubblicate e preceduti da un’accurata postilla critica a firma di Giuliano Ladolfi, descrivono una condizione di orfanezza assunta a metafora quasi ossessiva di una condizione esistenziale comune, tra percezione lacerante della colpa e desiderio di rimozione. E anche il dettato poetico, “sporcato” da espressioni gergali e tic verbali, si fa specchio dell’onesta rinuncia a dire verità risolutive: «Così come orfani del mondo / incatenati nella febbre a vita / del giorno: è così, sì, va bene…», cui fanno eco i versi «Anch’io sono colpevole del male / che regna vomitevole e banale».
Nell’introdurre i testi di Anna Ruotolo, Maria Grazia Calandrone ne sottolinea con efficacia la vocazione a innestare un produttivo dialogo tra dimensione celeste e dimensione umana, seguendo la rotta indicata dalle «stelle comuni, evidenze della bontà di ognuno» che «proprio a causa di questa loro presenza ubiqua» fanno segno al «rapporto tra uomo e uomo — e tra uomo e natura». Cifra specifica della scrittura di questa giovane autrice è la tendenza a iscriversi entro costellazioni dialettiche — tra interni ed esterni, solitudine e «tuttitudine», singolare e plurale —, secondo uno sguardo capace di farsi davvero plurale: «I singolari sono plurali / dico casa e ne dico mille / perché se guardo fuori da qui / tante ce ne sono, / pulsano da non finire […] ma chiama, chiama tutti / con centomila nomi esatti / si esce, così, infine, dalle dimore / e camminiamo in stormi / si prova a fare bene / tutto e forte, tutto al plurale / per una volta tra le altre volte».
Ancora una volta è l’emblema della figura paterna, in senso tanto metaforico quanto reale, a fare la sua comparsa nei versi di Giulia Rusconi, una delle voci sicuramente più originali del panorama poetico attuale per la capacità di combinare psicologia del profondo, «con punte di orrore quasi onirico», per usare le esatte parole di Anna Maria Carpi, con un ordito prosodico semplice, deprivato di orpelli stilistici. Ecco un passo estratto dalla serie L’altro padre: «Mio padre numero quindici / corregge la mia postura. / Precaria mi aggrappo al suo braccio / lo conosco a memoria. / Mio padre — l’altro — non lo tocco / mai neanche per sbaglio. / «È questo che cerchi, il contatto?» / Il contatto sì il pezzo mancante / della “casa”, delle cose».
Elementi di originalità presenta anche il percorso poetico di Sarah Tardino, di cui vengono proposti alcuni testi dall’ultima raccolta I giorni della merla (Lietocolle, 2011), preceduti da una nota esegetica di Rosita Copioli che ne rileva i tratti distintivi: la «fascinazione arabizzante», una «passione per il racconto instancabile» e la «pronuncia androgina». Nel segno di un fiabesco quasi stregonesco e del meraviglioso si collocano, per esempio, i versi seguenti: «Sono la merla e i suoi giorni, / la maga e l’ombra della rosa, / l’aprile della vendetta sotto mentite spoglie, / la vita che assalta con un segno, / il baro salvato dall’ironica sorte, / la ruota da cui nessuno ha scampo: / sono la fedele assassina!».
Si può senz’altro concordare con Gian Ruggero Manzoni, secondo il quale la poesia di Francesco Terzago si connota per la dinamica ossimorica di una «presenza-assenza» volta alla messa in scena di figure recuperate a una memoria insieme individuale e storica, secondo una modalità anche teatrale: «Mia nonna mi chiamava tesoro, lipscén / diceva e mi appoggiava una mano sulla testa / e mi diceva che era stanca. Vedi lipscén le stelle / che sono sopra di noi, il cielo, — l’universo che / non ha confini pensa — a tutte le cose che ci sono / dentro pensa agli anni che ci separano e pensa / a quante persone, in questo preciso momento, / ed è possibile che sia così».
Chiudono l’antologia alcuni testi selezionati da L’estraneo bilanciato (Stampa, 2009), l’ultima raccolta pubblicata di Matteo Zattoni (1980), tra gli autori senza dubbio più maturi della sua generazione, in virtù di uno stile ben calibrato e di una materia poetica mossa da intenti conoscitivi. Attraverso una ricezione attenta della lezione dei grandi poeti del secondo Novecento, la scrittura poetica è investita di una valenza etica, oltre che estetica, riconquistando così la sua originaria funzione sociale. Quella di Zattoni è poesia «in uno stato di attesa» — come scrive nella sua densa introduzione Alberto Casadei — , sospesa in precario equilibrio sul filo dell’esistente. Una situazione ben riflessa da alcuni versi di Trapezisti: «c’è sempre qualcuno che rinuncia a qualcosa / di certo, alla tranquillità di una casa / per inventarsi un equilibrio nuovo / io guardo e non guardo, poi l’applauso / sorrido; loro non cadono».
A chiusura di questa panoramica, ecco un invito finale: lasciamole sedimentare, allora, queste voci, concediamo loro il tempo — e gli spazi — per tornare a parlarci, prima di sottoporle a nuova e più onesta verifica.
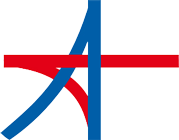


 Glauco Canalis
Glauco Canalis








Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!