IL CANONE POETICO D’OGGIDÌ NON È AFFARE NOSTRO
Ultime considerazioni sulla Repubblicana italiana dei poeti
A costo di risultare pedante, con l’intento di ribadirle e magari chiarirle definitivamente, torno su alcune questioni sollevate dal Catalogo di autori (poeti) “ragionevolmente” completo che ho da poco licenziato.
Lo sguardo imparziale. Ogni critico ha la sua poetica, implicita o esplicita, e quindi i suoi gusti. Può anche assumere una postura esplicitamente militante e quindi farsi partigiano di un determinato orientamento letterario. Non è il caso della Repubblica, in cui ci si sforza di mantenere uno sguardo imparziale sull’esistente, pur concedendosi delle ponderate licenze. Credo, come ho già spiegato nel libro, che anche un critico militante, qualora volesse stravolgere i valori in campo, non possa comunque prescindere dal “circostante”, dal reale contesto in cui ci si trova a operare, con la sua specifica distribuzione di forze. Ritengo inoltre che più efficaci saranno le sue valutazioni sovversive quanto più si radicheranno in un panorama storicamente condiviso.
Per esempio, ci sono autori imprescindibili anche per il racconto di una contemporaneità tanto multiforme e critica come quella contemporanea. Facciamo dei nomi, giusto per abbozzare un discorso consapevolemente incompleto che altri riprenderà. Farò ricorso a sigle molto generiche, imprecise, che hanno avuto però qualche spendibilità giornalistica per un certo periodo e mi sembrano ancora utili per un primo, rapido inquadramento.
Non si possono raccontare gli ultimi cinquant’anni di poesia prescindendo da figure come Milo De Angelis, erede di una tradizione ermetica e neo-orfica che ha avuto un’ampia e indiscussa influenza sulle generazioni successive; Maurizio Cucchi, rappresentante di una linea lombarda a lungo egemonica e figura ben insediata nel contesto editoriale; Cesare Viviani, poeta emblematico per la ricerca degli anni Settanta e con un’evoluzione stilistica poderosa, nonché autore di uno dei poemi più belli del secondo Novecento (L’opera lasciata sola; è opinione non solo mia, ma anche di un critico autorevole come Enrico Testa); Patrizia Valduga, che ha ridato impulso a una poesia dall’impianto metrico tradizionale, quando tutti ritenevano non fosse più possibile e sensato; Valerio Magrelli, altro poeta che ha avuto larga influenza sulle generazioni successive e che ha rappresentato un’opzione di chiarezza espressiva in controtendenza eppure di successo; Umberto Fiori, acquisizione più recente ma che, per certi versi, ridà vigore, sulla base di altri fondamenti teorici, a tale “linea della chiarezza” espressiva, contro ogni fumosità sperimentale o lirica. Altre figure autorevoli e utili per completare la mappatura da un punto di vista non solo poetico, ma anche geografico, potrebbero essere Biancamaria Frabotta (o Patrizia Cavalli?), Franco Buffoni, Antonella Anedda. Procedo ulteriormente contro i miei gusti e aggiungo Giuseppe Conte, a rappresentare l’area “mitomodernista”, e Claudio Damiani, della scuola romana dallo spiccato gusto neoclassico. Ci sarebbe necessità di rappresentare allo stesso modo un vasto arcipelago “avant-pop” e “sperimentale” (chiedo nuovamente venia per la genericità dell’etichetta, piuttosto equivoca), ma qui fatico a individuare campioni accertati. Lello Voce (che ha introdotto in Italia il Poetry Slam)? Aldo Nove (affermatosi anche, o soprattutto, come narratore)? Gabriele Frasca? Altri? Fate voi, a me interessa illustrare il metodo, non dirimere la questione. (Un’altra area pulviscolare che non ho rappresentato è quella “dialettale”. Ma è giusto “fare di tutta l’erba un fascio”? Chi si può ritenere un poeta dialettale “influente”, oggi? Mi giocherei la carta Edoardo Zuccato, nel caso).
Come avrete notato, ho scelto esempi che rientrano in una fascia generazionale abbastanza ristretta, che comprende gli autori immediatamente esclusi dall’antologia di Mengaldo e quelli che appartengono alla “generazione” (uso le virgolette perché si tratta di una categoria controversa, da accogliere in senso lato come fascia anagrafica) che ho analizzato nel saggio Poeti nel limbo. Mi sembra che questi autori, lungi dal documentare tutte le molteplici esperienze poetiche contemporanee (ormai, ogni poeta si smarca da qualsiasi corrente e persegue una ricerca individuale), riescano a segnalare le aree più nette. Non ho espresso gusti personali. Non pretendo di aver completato questa prima mappatura, ma anche chi volesse integrarla dovrà confrontarsi con una necessaria selettività, che il racconto (sintetico) di un’epoca pretende. Non credo di dover ripetere l’elenco (almeno parzialmente ragionato) di centinaia di autori che ho raccolto nella Repubblica per ribadire che questa lista è solo un punto di partenza, storicamente e obiettivamente, direi, condivisibile. Si desidera, alla luce delle proprie valutazioni, integrarlo e magari persino ribaltarlo? Accomodatevi. Già la storia compirà il suo lento lavorìo: molti autori “influenti” oggi finiranno per perdere la loro aura, appena chiuderanno il loro corso terreno. Mediterei in questo senso sulla fortuna, in vita, di Antonio Porta o Dario Bellezza, per darsi dei paradigmi di riferimento dal passato prossimo.
Ci sono, dunque, molti altri poeti da chiamare in causa, sia di poco più anziani o più giovani di quelli qui indicati. Rimando alla pagina 19 del mio saggio, in particolare. Al netto di qualche cambio di guardia tra i campioni prescelti, direi però che la maggior parte degli esclusi si può mettere in scia a questi (o altri) capogruppo. Non arrivo a definire linee, ma anche divaricando e intrecciando i vari posizionamenti individuali per suggerire costellazioni o gradazioni di parentele, forse il dibattito può, prendendo le mosse dagli apici qui annotati, cominciare. Un esempio, anche qui, per spiegare l’idea di costellazione o di gradazione. Stefano Dal Bianco è sicuramente voce ben affermata, oggi. Non è difficile posizionare la sua esperienza in una zona in cui si sovrappongono poetiche di cui si sono già scelti alcuni rappresentanti. Nello specifico, Dal Bianco può occupare l’incrocio fra un’area di influenza lombarda e romana. È il poeta stesso a esplicitare i propri riferimenti in autori “milanesi” (De Angelis e Viviani su tutti), in Magrelli e nella coetanea vicenda di “Braci”, rivista romana animata da Colasanti, Lodoli, Bre e Damiani. (Confessione: personalmente, io avrei inserito Dal Bianco proprio al posto di Damiani, preferito nell’elenco di cui sopra per ragioni “geopoetiche”).
A questo punto, come accennato, si potrebbe dissentire sul valore dei nomi scelti. Alessandro Ceni è preferibile a De Angelis? A prescindere dal fatto che non occupano esattamente lo stesso territorio poetico, si porti pure avanti con convinzione questa battaglia letteraria. Ma non c’è dubbio sul fatto che Ceni sia, al momento, autore di nicchia e De Angelis abbia un ruolo di spicco all’interno del sistema letterario contemporaneo. Lo stesso discorso si applichi, volendo, per Riccardi e Cucchi, o Pontiggia e Conte. E così via.
Ma perché questo o quello “al posto di” quell’altro, e non entrambi? Eh, non venite a ricordarlo a me, che ho chiamato in causa oltre seicento poeti, e per giunta frutto di una già ardua selezione… Io non sono affatto contrario a un discorso ampio e vario sulla poesia e sui poeti d’oggidì, ma ritengo che questo sia lo sguardo approfondito dell’esperto. Ciò che oggi manca è la capacità di costruire una sintesi credibile, da cui ripartire per qualsivoglia revisione. Una narrazione di partenza della nostra epoca. C’è bisogno di ricordare la voragine di oblio o confusione che, complice l’Accademia, si apre nei discorsi condivisi e nei manuali che, dopo Montale, faticano ad assimilare compiutamente figure del calibro di Sanguineti, di Sereni, di Luzi, di Zanzotto, di Raboni, di Pagliarani? Ci si vuole rassegnare alle mode, alle pressioni mediatiche, alle ragioni non sempre lucidamente letterarie che suggeriscono le Alda Merini del caso? E, senza snobismi sospetti, quale peso si vorrà attribuire alla capacità di raggiungere un pubblico straordinariamente vasto per la poesia, come accade per Mariangela Gualtieri o Chandra Livia Candiani?
Una volta avviato il dibattito e recepito un nucleo di base, ci si potrà espandere in altre direzioni, fino a inglobare gli outsiders che si ritengono, a ragion veduta, necessari. Mazzoni, Benedetti, Febbraro, Calandrone, Pusterla, Cappello… Si dia la stura ai tanti talenti, anche già ben attestati, che ciascuno vorrà individuare nel panorama odierno. (Mi sono fermato, si noti la grazia, alla “generazione” che precede la mia e che identificherei approssimativamente, seguendo l’indicazione di Elisa Donzelli, con i nati dal 1968).
Chiariamo: non è questione di stabilire un canone, che è sedimentazione di molti decenni e rimane riplasmabile persino nei secoli, e dunque non è affar nostro. È questione di ingaggiarsi nel presente per passione e responsabilità comune e, di conseguenza, porre basi non completamente aleatorie per un profilo dell’epoca riconoscibile a distanza.
A livello accademico, in questi anni una delle poche realtà che è stata apprezzata è quella (e finalmente ci si smarca dall’arcipelago fin troppo generico dell’area “sperimentale”) che, per dare due estremi riconoscibili, si situa fra la costituzione del gruppo GAMMM e l’antologia Prosa in prosa, con sconfinamento dal territorio poetico fino ad arrivare a un’ipotesi di Postpoesia (si veda Jean-Marie Gleize, Qualche uscita. Postpoesia e dintorni, Roma, Tic, 2021). Siamo, con questo, entrati nel vivo della mia generazione (gente che comunque si aggira attorno ai cinquant’anni, autori dunque nel pieno della maturità). Attorno a queste esperienze si è creata una vasta area di scritture, al solito, molto differenti fra di loro, ma possiamo cominciare ad annotare i nomi di Marco Giovenale e Michele Zaffarano e, spostandoci ancor più verso la prosa (distinzione che tuttavia avrebbe perso di significato), Alessandro Broggi e Gherardo Bortolotti.
Mi sembra che, per quanto sia lecita questa predilezione da parte dei critici che la sostengono (“questi poeti compiono la stessa rivoluzione in poesia che si è compiuta in pittura quando si è passati dalla raffigurazione all’arte informale e concettuale”), storicamente non si renda giustizia ad altre autorevoli esperienze o riviste: “clanDestino” capeggiata da Davide Rondoni, altro nome molto ricorrente, “Anterem”, “Atelier”, l’officina bolognese siglabile sotto l’esperienza di “Fuoricasa” che ha come principale esponente Alberto Bertoni… (l’elenco è solo avviato). Il problema, se tale è, sarà affrontato da chi di dovere.
Potevo esserci anch’io. La massa critica di oltre seicento poeti catalogati nella Repubblica fa impressione. Si proclama “ragionevolmente” completa, anche se, ovviamente, nessuno è onnisciente e il territorio odierno delle scritture poetiche ha troppi percorsi sotterranei, troppi anfratti nascosti, troppe nicchie che per necessità di sopravvivenza si autoescludono e autodeterminano, per supporre di conoscerle tutte. Nonostante ciò, la campionatura è sufficientemente vasta. Qualche manciata, o forse persino qualche decina di autori che “dovevano” esserci, non destabilizzeranno l’insieme. Con ciò, ben vengano le scoperte meritevoli.
Ma, naturalmente, c’è chi mugugna o esplicitamente lamenta di essere stato trascurato. Risponderei con due argomenti.
Il primo. Se anche un poeta non incluso valesse tanto quanto uno inserito nel catalogo, occorrerà insistere sul concetto di campionatura. Diversi nomi che si trovano in quelle pagine potrebbero essere sostituiti da altri di analogo valore, ma il punto è proprio che il poeta escluso non presidia, in quanto simile ad altri, un’area poetica significativamente diversa e dal valore storico sufficientemente attestato per rivendicare una specifica visibilità.
Il secondo. Si è certi, a parità (ideale) di valore letterario, di meritare attenzione al posto di altri del Catalogo? Prima di affermarlo, si verichino i crediti impliciti di coloro che ho chiamato in causa. Si vedrà che molti vantano una lunga carriera, che non è una semplice presenza sul campo, ma anche una sedimentazione di vari riconoscimenti. E non penso a quelli di scarso o nullo valore (i trofei dei concorsi minori), ma ad attestati di stima da parte di altri autori o meglio ancora di critici autorevoli, una certa riconosciuta area di influenza, la partecipazione a riviste, eventi, dibattiti significativi, la pubblicazioni in sedi prestigiose (al netto del cataclisma editoriale che si è compiuto dagli anni Settanta a oggi, specie in ambito poetico), e così via. Certo, alcuni di questi criteri sono stati utili, nella mia disamina, per includere poeti evidentemente non meritevoli, ma buoni per testimoniare la complessità del discorso, le magagne del sistema, le difficoltà di valutazione: piccoli casi sintomatici, insomma.
Conclusione: il problema non è esserci o non esserci, ma comprendere che esserci o non esserci non cambia nulla nel contesto generale, ma solo nella propria percezione narcisistica.
Un caso: Ivano Fermini. A un anno dalla chiusura dei lavori per la Repubblica e a pochi mesi dall’uscita del volume c’è stato il rilancio di un poeta caduto precocemente in oblio. Si tratta di Ivano Fermini (1948-2004), di cui ora si può recuperare presso l’editore MAGOG il volume Nati Incendio (ma il libro include anche l’opera precedente, Bianco allontanato). La cura del progetto è di Aldo Nove. Di Fermini (che prese parte alla vicenda della rivista “Niebo”) scrisse a suo tempo De Angelis in Poesia e destino. Basterebbero queste coordinate per affermare che il nome di Fermini “doveva” stare nel catalogo di autori contemporanei. La difficoltà di reperire libri introvabili e l’impressione di una poesia più che oscura, al limite dell’accostamento di immagini e parole in modo gratuito, benché suggestivo, nei pochi testi che mi era capitato di leggere, si potrebbero addurre come scusanti; ma qui non interessa difendere il “perimetro ragionevole” dell’analisi condotta, quanto esaminare un caso nella sua possibile evoluzione.
Fino ad ora Fermini è stato una meteora, nella galassia della letteratura contemporanea. La sua riscoperta riuscirà a imporlo tra le stelle fisse della nostra costellazione? Ancora una volta, esplicito ragionamenti “puramente critici”. Avessi avuto, fin dalle scarse letture che mi avevano ripoposto il suo nome, un’impressione positiva, il mio gusto personale avrebbe già spinto per un suo inserimento, almeno all’interno della cerchia più ampia. In quella addirittura ristretta ho inserito, invece, Simone Cattaneo, simile a Fermini per certi tratti tragici che ne contrassegnano la biografia. La conoscenza diretta e la frequentazione in vita giustifica questo trattamento diverso? Ovviamente, i rapporti umani contano, in ogni settore, e la letteratura non fa eccezioni. Condividere le passioni sportive insieme a un altro poeta di fronte al medesimo schermo può far la fortuna di qualche autore emergente ben più che l’invio di una silloge che finirà nella pila periclitante delle proposte accumulate sulla scrivania. Fra alcuni critici e autori si stabilisce un rapporto di affetto e non solo di stima (sotto la sigla Quarant’anni d’amicizia Gianfranco Contini licenziò i suoi Scritti su Carlo Emilio Gadda), ma ci sono parametri diversi per spiegare la scelta. Primo dato: Cattaneo ha avuto la forza (intrinseca) di suscitare attenzione anche al di fuori della sua cricca (attenzione, utilizzo il termine “cricca” in accezione scientifica: lo mutuo da Guido Caldarelli, Senza uguali. Comprendere con le reti un mondo che non ha precedenti). L’autore di Peace & Love è stato valorizzato anche all’esterno della cerchia di “Atelier”. Secondo dato, questa volta diacronico: anche con il passare del tempo, i versi di Simone hanno conquistato attenzione in autori più giovani, che non lo avevano conosciuto direttamente. Terzo dato, particolarmente importante: la sua poesia ha esplicitamente influenzato la scrittura di altri (emblematico il caso dell’Umana ferocia di Giorgio Anelli).
Al momento, non mi sembra che la poesia di Fermini abbia avuto la medesima forza di propagazione, ma magari siamo solo agli inizi di questo processo. Staremo a vedere, pronti a registrare la sua eventuale emersione. I tempi sono comunque ancora molto ristretti perché il giudizio sia “storicamente comprovato” per entrambi i poeti; senza dimenticare che persino la storia può essere gabbata, con efficaci riscoperte anche a distanza di secoli.
Ma forse è possibile dire di più, sulla questione. Il caso Fermini solleva almeno altre due problematiche. La prima è una faccenda di poetica, la seconda di qualità del discorso critico.
Le poesie di Fermini sono fortemente caratterizzate, e non è affatto un male. La materia trattata appare, almeno di primo acchito, sfuggente, e anche a livello tematico faticano a emergere nuclei ben definiti – ma la poesia non è un veicolo di comunicazione, si dirà. Eppure, in mancanza di appigli formali, l’originalissima poesia di Fermini non è dissimile da molti esiti poetici che si registrarono non solo nei pressi di “Niebo”, ma di tante altre fucine sperimentali tra anni Settanta e primi Ottanta. Ciò significa che al momento la sua poesia è rappresenativa di un’area in cui spiccano altri campioni. Su tutti, il già citato De Angelis. Quella di Fermini, anzi, può risultare un’esperienza ancor più radicale e corre il rischio che una poetica così pura fatichi a connettersi, a dialogare con altre esperienze. Mutato il clima culturale e la poetica dominante, il pericolo è giustappunto l’oblio. Ora, in epoca di post-lirica, di scritture che non significano ma hanno senso come installazioni, di procedure compositive “a freddo”, di registri antiretorici, ovvero ben congegnati retoricamente ma su timbri impersonali (l’opposto del vaticinio attratto dal sublime), di voci interessate a mettere in luce vicende “infraumane”, e via tratteggiando alcuni dei principi che lampeggiano nell’aere dell’oggidì, la poetica di Fermini riuscirà ad attecchire? È possibile. Forse i tempi sono maturi.
Qui val la pena passare al secondo punto. Dovrebbe essere infatti la qualità del discorso critico a mediare tra una proposta e il clima culturale dell’epoca. Altrimenti, si tratterà sempre di una rivendicazione partigiana, di una valorizzazione interna a un’area letteraria che, in assenza degli altri fattori di merito summenzionati, faticherà a stagliarsi in un orizzonte tanto caotico come quello attuale.
Aldo Nove ha il merito di essere il capofila nel rilancio di Fermini e, si spera, avrà peso mediatico affinché di Nati Incendio quantomeno si parli a sufficienza. L’apparato che introduce le poesie non riesce però a sfondare un certo linguaggio giornalistico. Non è un rimprovero a Nove, che critico non è, ma il riconoscimento di un limite dei nostri tempi: la mancanza di un fitto dibattito critico, che intrecci più voci di vedute auspicabilmente diverse ma tra loro dialoganti, e che si tramuti in argomenti razionalmente convincenti che possano conquistare consensi nella cerchia dei lettori (che è rappresentata dai poeti stessi – ma questo è altro problema). Parlare di “caso unico” in Italia (ogni generazione ha il suo poeta tragico da riscattare), lumeggiare i dettagli borderline di una biografia comunque sfuggente e giustificare l’oscurità testuale tautologicamente, non credo sia il migliore servizio alla causa. Ecco un rapido repertorio di citazioni:
Già distante nel suo farsi, ci consegna con precisione l’impossibilità di un senso che non sia un viaggio a tutti i costi nell’Altrove.
Il deserto sintattico in cui si incamminano i significanti dei testi di Bianco allontanato e Nati incendio sono la testimonianza più preziosa di una solitudine che convulsivamente, come nel Beckett degli ultimi testi, sigilla il clangore delle ossa della lingua, le loro cartilagini, nel vizio dell’origine, nell’ecolalia che si rifiuta di sottostare alla dittatura dei significanti. Se qualcosa qua può apparire insignificante, o peggio ancora incomprensibile, lo è in virtù del rifiuto di qualunque congettura di storia. Un’eternità sempre tutta espressa nell’adesso, ci regala Fermini.
Eppure là, più in là, c’è qualcosa di inestimabile.
Ivano ce la indica esagerando. Ce la indica, non ce la “spiega”. Pochi poeti hanno con tale intensità testimoniato l’abbagliante parata dei simboli che con dovizia ricuciamo per chiuderci in un sogno.
Il clamore della vita che Ivano Fermini ci dona è subitaneo, feroce e infantile. Una sorta di realismo estremo, che si scolla dalle leggende in cui si accampano i nostri desiderata in riparo da uno spavento originario che non vuole essere placato. Generatore di attimi in rivolta, vortici di sensi friabili, ossimoriche malebolge angeliche.
Un codice alchemico, un trattato di simbolica arcaica e istantanea in cui rovistare tra formazioni subitanee di miti e il loro affondo confusionale in senso infantile, titanicamente fiabesco, in qualche modo assolutamente realistico.
Ci fermiamo qui, più o meno a metà dell’introduzione. E ci chiediamo: ma chi, se non il critico, dovrebbe essere esattamente colui che almeno azzarda un tentativo per recuperare la «chiave perduta» del «codice alchemico» del poeta? Citare, dopo enunciati come quelli riportati qui sopra, testi di ancor più ardua decifrazione, non dimostra nulla.
Ribadiamo, non è colpa di Aldo Nove: non ci si attendeva da lui un affondo critico più dirimente. Inoltre, diamo pure per scontati ai giorni nostri rimuginamenti da Heidegger, Lacan e Blanchot. E concediamoci infine di vivere tempi in cui una poesia non va spiegata, perché va solo contemplata, e capita in base al contesto in cui essa si pone come installazione. Ma tutti questi presupposti generano le cortine di nebbia che impediscono di conoscere e valutare il panorama letterario odierno. Manca qualcosa di più importante, forse di meno nobile e piretico ma più utile e semplice. Si sente insomma la potente nostalgia di una critica testuale, che mostri e renda pregnanti i dettagli dell’opera, che valuti i fatti linguistici e retorici alla luce, certo, di un proprio specifico orientamento poetico, ma che non usi il testo come uno specchio per il proprio autotelico discorso, bensì come luogo di verifica, in cui lo stesso fantomatico lettore sia convocato e guidato, perché partecipi al circolo ermeneutico, prolunghi l’atto creativo e arrivi, infine, alla valutazione dell’esperienza estetica.
È preferibile una cauta e ponderata espressione di gusto a una sensazionalistica e dogmatica rivendicazione di valore assoluto. E conoscere e inserire un autore in un contesto “ragionevolmente” completo dà forza all’argomentazione. Ogni voce, in sé stessa, è unica e preziosa, ma la letteratura è un’opera comune che spinge verso l’eccellenza perché impone il confronto, relativizza qualsiasi sguardo. Persino quello dei classici; figurarsi quello dei contemporanei.
Altre aree da inglobare. Sconfinamenti. Ognuno ha i suoi limiti. E i confini sono convenzioni. La poesia, poi, per sua natura, non accetta steccati o, per dirla con Gleize, essa «consiste, per una parte essenziale, nella propria autonegazione, nella propria autocritica, nella propria più o meno violenta autodistruzione. In questo senso ogni vera poesia è antipoetica».
Devo quindi ammettere che nel mio percorso di perlustrazione del contemporaneo poetico non ho avuto abbastanza risorse per annettere alcuni territori, approssimandomi ai quali mi sentivo troppo smarrito (si dica pure: incompetente). I miei sassolini bianchi per ritrovare la strada di casa sono stati i libri. Dunque, di fronte alla poesia espressamente pensata per la diffusione sul web o concretamente incarnata in performances di varia natura o, infine, pronta ad abbracciare l’arte, secondo svariate modalità tipografiche, mi sono guardato bene dall’emettere sentenze. Ricordo, anni fa, un’antologia firmata da Alberto Bertoni che registrava non solo libri italiani di poesia ma anche i suoi “dintorni”: includeva quindi anche testi di canzoni (Trent’anni di Novecento, Book Editore, 2005). Del resto, il Nobel per la letteratura assegnato nel 2016 a Bob Dylan fa giurisprudenza.
Chi ritiene che un ulteriore allargamento di orizzonte sia necessario, ha tutta la mia stima e la mia ammirazione. Consiglio di partire da quelle che sono le guide a cui mi sono affidato io, per le poche sortite fuori dal mio orizzonte: Asemics. Senso senza significato. Note sulla scrittura asemica 2006-2023, di Marco Giovenale, e Il metaverso. Appunti sulla poesia al tempo della scrittura automatica, di Gilda Policastro, al quale aggiungerei anche il precedente, sempre della stessa Policastro, L’ultima poesia. Scritture anomale e mutazione di genere dal secondo Novecento a oggi (più teorici e meno avventurati oltre i miei limiti di perlustrazione, ma comunque utili, altri due titoli delle edizioni Tic: Gian Luca Picconi, La cornice e il testo. Pragmatica della non-assertività, e Florent Coste, Grammatica della letteratura).
Qualche limitazione di poetica. Avevo avviato queste postille al mio Catalogo ricordando che ogni critico ha il proprio punto di vista, quindi una specifica poetica, anche quando si impegna ad assumere una posizione imparziale nella valutazione del contesto.
Che cosa potrei aggiungere, attorno alla mia personale poetica, dunque? Al netto di alcune scelte qualificanti documentate nella Repubblica italiana dei poeti, che denunciano, nel quadro idealmente obiettivo che ho tentato di comporre, le mie predilezioni, aggiungerei qualche altra considerazione.
Pur comprendendo i diversi posizionamenti all’interno del contesto odierno, non sopporto la contrapposizione faziosa, la partigianeria che nega le ragioni dell’avversario. Non mi sono impegnato a documentare, per quanto nelle mie competenze, scritture molto diverse fra di loro per semplice attitudine all’inclusione, ma perché non riesco a concepire una sola modalità (teorica) per la poesia. Detto altrimenti, mi aspetto sempre che sia il testo a convincermi della bontà (almeno parziale) di una poetica specifica. Non sono a priori contro la poesia “di ricerca”, la poesia “civile” o la poesia “semplice”, per ricorrere a qualche etichetta che fa capolino tra le mie pagine, magari proprio per stigmatizzare alcune personali riserve. Ho ragioni teoriche per diffidare di simili opzioni, ma attendo sempre la sentenza della pagina. Sarei più propenso a riconoscermi in un’area post-ermetica e lirica, e bendiposto nei confronti del lavoro metrico-ritmico o, in generale, di un approccio più tradizionale alle questioni inerenti alla forma della poesia? Quanto finora ho pubblicato come poeta lascerebbe intendere di sì, ma ciò non significa che non sia consapevole della saturazione lirica della tradizione occidentale e dello sdoganamento del poetese più trito a cui abbiamo assistito a seguito del crollo delle istituzioni che in qualche modo, fino a pochi decenni fa, contenevano la poesia entro ambiti più elitari. Molti dei presupposti che stanno alla base degli orientamenti del già citato Gleize sono ampiamente condivisi non solo dal sottoscritto, ma direi da qualunque scrittore minimamente accorto e consapevole. Anche se poi la messa a terra di tali concetti può risultare ben differente.
Lavoriamo su un principio concreto: la scomparsa dell’autore. Se, dal Romanticismo in poi, l’autore è divenuto un feticcio pericoloso o una vera e propria superstizione pestilenziale, e il culto di tale figura è alla base del poetese egolatrico largamente diffuso (per tacere di quanto l’editoria odierna sia più interessata al personaggio che precede il libro piuttosto che all’opera in sé), senza disconoscere il ruolo di regia che il poeta assume nei vari processi “non creativi” che si offrono come metodo per svariate scritture odierne “impersonali” e/o “automatiche”, la mia esperienza di lettore, chiamato a interagire e a dare senso all’opera, mi lascia molte volte interdetto di fronte alla carica di mera suggestione, di retorica, di gioco di sponda con il contesto che ritrovo in molte scritture “di ricerca” (anche se poi, gli stessi difetti, ma in modalità diverse, li ho a suo tempo additati in ambiti poetici più tradizionali). Che la connessione sorprendente di immagini o parole nasca da un impulso interno (l’inconscio o, meglio, il sovraconscio dell’autore) o da un procedimento esterno più o meno volontario o persino da una macchina, può non essere determinante. L’autore comunque scompare nell’opera. Persino le sue eventuali intenzioni vengono assorbite. L’opera acquista un senso malgrado l’autore, e tale senso è sempre legato al contesto.
Ha un bel dire Paolo Giovannetti che La poesia d’oggi è (anche) “lirica”. E questo non è un insulto (questo il titolo del primo capitolo del suo studio La poesia italiana degli anni Duemila. Un percorso di lettura). In effetti, per chi non si smarca con decisione dal proprio stesso feticcio autoriale, portare avanti in modo credibile e riconoscibile la propria ricerca risulta più arduo che per altri. Lo ammette Giovannetti stesso. Una scrittura che si presenta “strana”, invece, ha più possibilità di essere giustificata come “installazione” (Il libro come installazione è giusto il secondo capitolo del saggio). Ovviamente, non si sta qui affermando che ciò che è dichiaramente non-lirico, quindi “di ricerca”, ciò che insomma si vuole barthesianamente “scrittura” e rigetta la “poesia” (troppo compromessa con la stilizzazione, indizio di quanto il testo sia contaminato dal suo ingombrante “autore”), sia meramente stravagante e privo di consistenza letteraria. Si ribadisce l’idea che il confine tra “lirico” e “di ricerca” non è un confine reale, ma una membrana altamente osmotica. Il grado zero della scrittura non esiste. Lo stile è inevitabile. Persino di fronte all’opera di un’intelligenza artificiale, l’input determinante arriverà sempre da un autore.
Per necessità di sintesi, si rischia però a questo punto di condensare troppi ragionamenti finendo per risultare, volenti o nolenti, semplicistici se non confusi. In fondo il presupposto che premeva ribadire era semplice: la riprova di ogni poetica sta nelle qualità intrinseche dell’opera. Se le qualità dell’opera sono legate unicamente al contesto, all’orizzonte della contemporaneità, ovvero se il suo effetto poetico o letterario che dir si voglia è in relazione alla configurazione del circostante e gioca di sponda con le attese standard, va da sé che al successivo mutamento di orizzonte, anche quella forma di avanguardia finirà nel museo della storia. Perché dada non significa nulla.
In un recente articolo (Senza trama, sulla rivista online “Snaporaz”), la già citata Gilda Policastro ha lanciato un estivo e rinfrescante gavettone (l’immagine è sua) in cui chiarisce che «chi scrive versi ha rinunciato a tre cose fondamentali per la poesia di tradizione: l’ermetismo, l’endecasillabo, l’enjambement». Adoro i gavettoni. In collegio, ai tempi dell’università, avevo un compagno che ne realizzava di incredibili: a parte i mitici “novanta litri” destinati alla camera presa di mira, dimostrava l’abilità di un ingegnere nel costruire, con mezze bottiglie di plastica e un sacchetto, un gavettone che avrebbe riversato il suo contenuto solo dopo aver raggiunto la debita distanza dal punto di lancio, quindi rinfrescando chi di dovere, sebbene seduto in cortile non in prossimità dell’edificio. Ora, il naturale effetto di un gavettone è un irrigidimento dei muscoli. In effetti, la mia prima reazione di fronte alle tre rinunce della poesia odierna sarebbe quella di controbattere che, come poeta, a dire la verità, per principio non rinuncio proprio a nulla; ma siccome non posso fare affidamento su me stesso in quanto autore, godiamoci il successivo rilassamento. Ma sì, che goduria, rinfreschiamoci corpo e mente, liberiamoci da un po’ di tuniche ingombranti e approfittiamo dell’estate. E, tuttavia, la prima cosa fondamentale eliminata mi risulta un po’ ermetica, da comprendere. Che cosa sarebbe l’ermetismo da cui occorre prendere le distanze? Non voglio andare per il sottile, io stesso finora ho utilizzato categorie molto fragili e generiche. Subito dopo, Policastro precisa: «Al simbolismo metafisico si è andata preferendo quella che Gianluca Picconi, critico di poesia, ha definito l’opacità e indeterminatezza se non assenza di referente». Sì, credo più o meno di aver capito, ma di opacità e di assenza di referente si parlava anche a proposito delle poesie ermetiche. E lo stesso Luzi, quando mi capitò di interrogarlo sull’ermetismo di cui veniva indicato come principale rappresentante, quasi sbottò (proprio lui, sempre tanto sornione) affermando che in fondo nemmeno lui aveva ancora capito che cosa diavolo fosse, questo ermetismo. Dunque, provo a interpretare: qui si vuole abbattere l’impostazione di voce, il tono vaticinante del Poeta, rigorosamente con la maiuscola. Bene, detto così mi sentirei d’accordo. Lascerei aperta la possibilità, però, che una voce alta, sublime, perché effettivamente “ha da dire” (ahi, anatema!) cose alte e sublimi possa, per specifiche capacità, risultare credibile. O, magari, suonare credibile al prossimo cambio d’epoca. Com’era l’adagio? Nessuno è profeta… Cioè, sì, qualcuno lo è, ma da un’altra parte (vale la pena ricordare che l’Occidente e la sua parabola culturale non sono il mondo intero?). La seconda superstizione riguarda l’endecasillabo, che poi, seguendo il ragionamento, indica il verso squillante, “cantato”. Qui agganciamo il terzo feticcio: l’enjambement. Insomma, il verso non esiste più, esiste la “riga”; per dirla fino in fondo, «la poesia […] non va più a capo.» Ora, io condivido l’obiettivo finale:
non è pù tempo di raccontarci storielle intimiste, in versi come in prosa, con un esito atteso e previsto e un armamentario di strumenti e convenzioni abusate e desuete, bensì di produrre significati a partire dal combinato di operazioni che entrano in campo nell’atto della scrittura e della lettura consapevole,
ma non me la sento per nulla di accettare alcuna prescrizione. Sarà colpa della fiaba di Barbablù, ma appena mi ordinano di non aprire quella porta… Ora, anche qui, non voglio affermare implicitamente che il confine tra poesia e prosa sia così netto. Finora, mi sembra, ho parlato di membrane (e quindi di convenzioni storiche) facilmente attraversabili. E da tempo immemorabile la poesia si sta muovendo verso la prosa, ovvero fa diventare poetico l’(apparentemente) impoetico (ricordate la sentenza di Gleize?), ma che l’a capo della poesia abbia perso di senso, non mi trova d’accordo. In quell’a capo c’è una sovversione della logica, la radice di una modalità di pensiero diversa, che non soltanto si apre a più significati, ma che scavalca il principio di non contraddizione stesso. Mi sia concesso, a questo punto, per evitare riferimenti altisonanti e restare sul concreto, una esemplificazione personale. Giusto in questi giorni (ah, le coincidenze che mettono in moto continui ripensamenti) mi era capitato di scrivere una poesia, forse un po’ ermetica (!), che definirei “civile” (mi costituisco, sono colpevole e contraddittorio!). Ebbene, verrà liquidata come brutta o nemmeno presa in considerazione, ma non è questo il punto. Il fatto è che in quella poesia avevo scritto, in un passaggio: «Lo stato d’animo è buono». Ma nella fase di postproduzione (una volta si sarebbe parlato di limae labor) mi sembrava che l’accezione politica del primo sostantivo si sciogliesse, nella “riga”. In effetti, io mi stavo raffigurando contemporaneamente due pensieri: 1) il benessere di uno stato d’animo, in contrapposizione però con 2) l’ipocrisia di uno stato buono d’animo (ma non nei fatti). Tutto molto contorto ed “ermetico”, lo ammetto. Ma ribadisco, non è una questione di valore, è una questione di modalità di pensiero. Ebbene, anche se l’idea dell’enjambement mi era già balenata, ma l’avevo esclusa (abbastanza consapevolemente, e suppongo per le ragioni che stanno alla base del divieto espresso da Policastro), alla fine mi sono arreso al testo, alla materia verbale che ha imposto il dettaglio: “Lo stato / d’animo è buono”. Saprà il lettore interpretare quella pausa? Saprà creare l’armonia fra diversi e persino antitetici messaggi imprigionati nella figura retorica? Ecco, forse adesso sì, giacché ho per l’ennesima volta peccato di autoesegesi, ma il quesito è valido anche al di fuori di tale esempio di comodo. E il punto non è stabilire un confine per cui ciò che va a capo e magari addirittura osa un enjambement non è poesia mentre ciò che è scritto in “riga” è diventato poesia – o che la prima sia una scrittura non consapevole e svalutabile, a differenza della seconda. Il punto è delegittimare una modalità di pensiero (che personalmente considero spiccatamente poetica) che potrebbe, malgrado tutto, rivitalizzare anche tradizioni che si vorrebbero abolite.
Quando i poeti di “ricerca” diventano così assertivi mi sembrano come quei cabarettisti che, tanto abili nella lettura della situazione, ti fanno sbellicare con la più banale delle freddure. Avete presente la situazione? Una barzelletta dietro l’altra, si ride ormai a crepapelle, si è saturi di risate a tal punto che si sta quasi male, si comincia a soffrire, e il genio arriva e racconta una “non-barzelletta”. Dopo un istante di imbarazzo, se davvero si è colto l’attimo giusto, tutti riprenderanno a ridere di gusto.
La nostra epoca vive di questi paradossi. Siamo (dal Decadentismo in poi) così saturi di cultura, che assistiamo all’inversione magnetica dei poli. Ciò che è prosastico diventa poetico. Ciò che è scandaloso diventa banale. Chi è frigido appare sensuale. Chi è cinico risulta profondo. Chi è sentimentale regredisce al sub-umano. E così via.
Tornando a noi. La poesia non è una barzelletta. La prosa in prosa è poesia solo per un momento. Poi, forse, sarà il caso di resettare il sistema.
Nella Repubblica metto in fila millanta poeti perché ciascuno si renda disponibile a questa pausa, a questo momento di disincanto, direi persino a questo spavento, propedeutico a uno scatto qualitativo (da compiere ciascuno a modo suo), dal momento che a livello quantitativo si pubblicano troppi libri, e non solo di poesia.
Nel separare i destini dei narratori (o quanto meno dei romanzieri mainstream, vero bersaglio polemico del suo pezzo) da quello dei poeti (o quanto meno dei più avveduti), Gilda Policastro ricorda come siano questi ultimi, ancora una volta, e con buona pace dei criteri puramente economici che governano i destini odierni, ad avventurarsi negli spazi di senso inesplorati che competono alla letteratura. Ma, a differenza di Gilda Policastro, pur senza sentirmi in opposizione alle sue istanze, non ingaggerei in questa avanguardia di ricerca solo le voci provenienti da una specifica regione del panorama odierno. E mi piace pensare che lo spettatore capace di sentirsi interpellato dall’arte concettuale possa essere anche e ancora lo spettatore capace di commuoversi pure davanti al bambinello stretto al seno della Madonna.
Tenere insieme le esperienze le arricchisce entrambe, oso pensare.
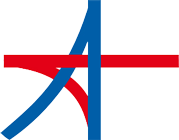










 foto di Mak_jp, a uso gratuito, da Pexels.com
foto di Mak_jp, a uso gratuito, da Pexels.com libero. Foto dal sito Pexels.com
libero. Foto dal sito Pexels.com
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!