Non è più un mondo da numeri 10. Quattro chiacchiere con Enrico Macioci su Calcio e letteratura
Caro Enrico, hai appena socializzato un pensiero che molti condividono da tempo: siamo diventati un Paese scarso, dal punto di vista calcistico. E continuiamo a sopravvalutarci, quando affrontiamo avversari con una tradizione meno illustre.
Forse questo non riguarda solo il calcio – ma passeremo alla letteratura gradualmente. Intanto, ho vissuto anch’io, insieme a tanti Italiani, questa domenica di metà novembre come una metafora di un bel capovolgimento: alla splendida vittoria di Sinner su Alcaraz nella finale delle Atp Finals di Torino è seguita una nuova umiliazione della nostra nazionale, travolta a pochi chilometri di distanza (Milano) da una Norvegia (già certa della qualificazione diretta ai Mondiali) che ha giocato in fondo per un tempo, e tanto le è bastato non solo per capovolgere il risultato, ma addirittura per infliggerci un poker memorabile. Il tennis ha superato il calcio, persino nello share degli spettatori televisivi. Noi due, figli del Mundial dell’Ottantadue, apparteniamo a una generazione che ha goduto, negli anni dell’adolescenza e della giovinezza, per un calcio italiano ai massimi livelli: i maggiori talenti del mondo venivano nei nostri campi e l’intera Europa ci guardava come un modello. Poi, che cosa è successo?
Caro Andrea, la prima cosa che balza all’occhio mi sembra la mancanza, scoraggiante, di talento. Noi, che un tempo potevamo permetterci la staffetta tra Rivera e Mazzola, tra Baggio e Del Piero e tra Del Piero e Totti, noi che tenevamo in panca Mancini e Zola, Signori e Chiesa (tutta gente che faceva cantare il pallone), ebbene adesso affidiamo la nostra fantasia agli esterni Dimarco e Politano, e laddove a dirigere il gioco avevamo Antognoni o Pirlo dobbiamo affidarci a Barella e Locatelli. Un salto (all’indietro) mostruoso, e dunque difficile da spiegare riferendoci a una sola causa. Le cause, dunque, devono essere parecchie. Provo a stilarne un rapido elenco: a) il fatto che i ragazzi non giocano più per strada, nei campetti, nei cortili, e dunque non apprendono più un certo tipo di creatività che ti viene dal dover improvvisare, dal dover scartare, oltre agli avversari, anche le macchine, gli alberi, le pietre, i ciottoli, gli ostacoli più vari, una creatività che insomma deriva dall’interazione con un contesto mutevole e imprevedibile; b) il fatto che questi ragazzi, abbandonati i campetti di periferia, si iscrivono alle scuole calcio; c) il fatto che le scuole calcio costano, e dunque sono per pochi; d) il fatto che molti allenatori delle scuole calcio soffocano già in giovane età l’estro calcistico, anteponendogli gli schemi, e che invece di puntare sulla crescita dei giovani puntano sulla propria (tradotto: è più importante vincere il campionato di categoria che alzare il livello del singolo). Quindi, ricapitolando, possiamo ravvisare due ordini di problemi. Il primo: giocano a calcio molti meno ragazzi di prima. Il secondo: il nostro settore giovanile soffre di carenze gravi, a differenza per esempio di quello spagnolo in cui, come ha spiegato Del Piero, si coltiva un grande rispetto per l’identità tecnica, e solo poi intervengono il discorso tattico e l’ansia da risultato.
Mi garba questo tentativo di spiegare qualcosa che racchiude anche un nucleo di imponderabile (il talento) a considerazioni strutturali. Del resto, ti considero un esperto nell’argomento, da quando a suo tempo ebbi modo di apprezzare il tuo Breve storia del talento, rivisitato l’anno scorso per le edizioni TerraRossa sotto il titolo L’estate breve. (Se penso a Sinner e alla situazione italiana, da un punto di vista di scuole e di campi, direi che il talento arriva davvero per miracolo, e solo in seguito trascinerà, nel migliore di casi, l’intero movimento e cambierà strutturalmente le condizioni di una disciplina sportiva – sarà anche per questo che sentiamo il campione altoatesino poco italiano e molti, anche da noi, apprezzano il più latino Alcaraz?). Sai che condivido le tue spiegazioni. Ho avuto due figli che hanno passato la trafila delle giovanili, in un caso anche con prospettive interessanti (poter passare al Novara, quando la squadra galleggiava tra serie A e serie B), e ho constatato di persona la povertà culturale e sportiva degli ambienti di provincia. A parte il contesto delle famiglie e del tifo, di cui tacere è bello, ho visto allenatori che imprigionavano subito, a sei anni, i ragazzi in un ruolo funzionale al mix della squadra, ovvero alla vittoria di partite e tornei inutili, dimostrando così di non preoccuparsi della formazione dei giocatori ma di compiacersi del loro ruolo. Patetico. Mi permetto anzi un paio di aneddoti significativi. Dopo anni con un allenatore (uno dei meno peggio, almeno a livello umano), la squadra del mio secondogenito è passata nelle mani di un giovane, che ha cominciato, regolarmente, a cambiare di ruolo i giocatori, anche tra un tempo e l’altro (difensori in attacco e attaccanti in difesa). Non solo, specie contro le squadre “materasso” che ci capitava di incontrare, chiedeva al portiere di uscire fino a centrocampo e oltre, e di partecipare così al gioco con la squadra, anziché stare ad annoiarsi isolato. Non gli importava di subire una rete da centrocampo (nell’età in cui spesso basta tirare alto per superare i portierini di turno anche ben posizionati) o di perdere qualche partita per una certa confusione tattica dei ragazzini: gli premeva che affrontassero situazioni nuove in modo da elaborare più abilità. A fronte dei risultati non in linea con la gestione precedente, ci fu una sollevazione delle famiglie, fino a ottenere l’allontanamento del mister “giovane e inesperto”. (Quella volta non riuscii a trattenermi e diedi apertamente degli ignoranti a certi genitori, e a certe mamme in particolare, fino ad accusare la società stessa, poco lungimirante e succube delle famiglie, che in quanto “paganti”, come hai ricordato tu, hanno fin troppa voce in capitolo). In un’altra occasione mio figlio, in una delle poche occasioni in cui si trovò in seria difficoltà di fronte a un’ala particolarmente veloce, venne spostato dall’allenatore sulla fascia opposta. Insomma: invece di lasciargli affrontare un problema e di sostenerlo (magari con indicazioni appropriate), cercò una soluzione tattica. L’allenatore degli avversari, che evidentemente era della stessa pasta, ovviamente chiese alla sua ala imprendibile di cambiare, a sua volta, fascia di competenza. Ecco, in una partita tra bambini i protagonisti erano gli allenatori. Ma non vorrei trascurare i tuoi primi argomenti, rispetto alla scarsa preparazione dei responsabili dei settori giovanili. Si gioca poco per le strade, in modo libero, ricordavi. Affermerei che i ragazzi sono sempre più ingabbiati, se non in salotti e divani dove vengono iperstimolati dalla tecnologia, in cortili iperprotetti. Ovviamente, capisco che la mia infanzia selvatica e fuori da ogni controllo oggi sarebbe (giustamente) percepita come troppo pericolosa, ma mancano occasioni sociali e spazi in cui il mondo dei ragazzi possa prendere forma compiutamente – altro tema che attraversa le tue storie, tra l’altro. È uno stereotipo da uomo ormai di mezza età oppure ti sembra un ragionamento sensato? Dal fronte della scuola mi rendo conto di come la perdita di destrezza fisica sia, di generazione in generazione, sempre più palese e che essa si tramuti in una perdita di capacità mentali nella gestione dello spazio, quindi, detto spicciamente, di capacità di ragionamento. Te la sintetizzo in modo addirittura brutale e in termini che non piacciono nemmeno a me: i giovani di oggi sono meno temprati caratterialmente, meno affamati, più viziati e protetti e, quindi, maggiormente a rischio di disperdere il loro potenziale, come una certa sequenza di talenti bruciati degli anni recenti parrebbe dimostrare (Balotelli, Cassano, forse lo stesso Zaniolo), oppure il talento ci sarebbe ma non siamo capaci, noi adulti, di intercettarlo e svilupparlo?
È davvero difficile stilare una diagnosi chiara e precisa dei problemi delle attuali giovani generazioni; il mio timore, infatti, è sempre quello di spacciare caratteristiche neutre e oggettive per difetti. Il mondo è cambiato, rispetto al nostro (siamo entrambi di metà anni settanta, se non sbaglio) in una maniera inimmaginabile, così tanto che forse stentiamo a rendercene conto, e cavalchiamo l’onda come surfisti sonnambuli. Direi che l’avvento di internet, che in Italia risale suppergiù al Duemila, abbia tagliato le nostre esistenze di uomini occidentali borghesi di mezza età in due: esiste un prima e un dopo. La scoperta del virtuale possiede davvero, secondo me, la portata storica immensa della scoperta del fuoco, o della ruota. Un altro mondo, letteralmente, a disposizione. Ma se noi abbiamo conosciuto il prima, se ce ne siamo imbevuti al punto da – spesso, non sempre – rimpiangerlo, i nostri figli sono nati e cresciuti nel dopo. Esagerando, ma nemmeno troppo, potrei affermare che loro rispetto a noi incarnano un’altra razza, un’altra antropologia. Ciò premesso, è senz’altro vero ciò che tu affermi a proposito della brusca diminuzione della libertà e (quindi) della responsabilità intesa come scelta consapevole – diminuzione che potrebbe riflettersi poi nello stile stesso dei modi di giocare, e quindi anche nel modo di interpretare il calcio. Prima c’era meno controllo sociale, e anche meno controllo tattico (me l’hai fatto venire in mente tu il parallelismo, forse azzardato o forse no. E penso anche ai ciclisti, che ormai gareggiano in simbiosi col computerino anziché ascoltare l’istinto o le sensazioni corporee). Eravamo più “selvatici”, meno “addomesticati”. E se non sono affatto sicuro che ciò significhi che eravamo persone migliori, sono pronto a scommettere però che in quel contesto avessero modo di crescere calciatori migliori. Improvvisare, inventare, scartare dalla norma, adattarsi, sfidare l’ignoto (e sfidare la regola!), reinventarsi: tutte qualità che chi giocava a calcio introiettava in automatico, senza sforzo, per strada o al campetto, con la stessa naturalezza con cui s’impara a camminare o ad andare in bici. Lo ha detto Alessandro Del Piero, lo ha detto Paolo Maldini. L’opinione di Maldini mi sembra particolarmente qualificata, non solo perché ha giocato ai massimi livelli mondiali, ma pure perché ha attraversato proprio queste epoche che stiamo delineando: ha esordito nel 1985 e ha smesso nel 2009, è partito affrontando Platini e ha finito affrontando Cristiano Ronaldo. Ebbene lui sostiene che il livello tecnico, nel tempo, è progressivamente sceso. Addirittura, per Maldini, nemmeno il livello atletico attuale sarebbe poi così superiore a quello del passato, perché prima a suo avviso ogni calciatore doveva coprire una porzione di campo molto più estesa. E in effetti, guardando una partita di oggi, salta all’occhio la rigida ripartizione delle zone di competenza, che ci riporta a quanto racconti tu circa gli allenatori delle giovanili e i loro precocissimi dogmi tattici. Quanto al discorso su Sinner talento generazionale e “fatato”, in grado di sospingere un intero sistema da solo, in un circolo virtuoso: concordo. Fu lo stesso anche con Tomba, nello sci. Ogni tanto, per fortuna, accade; perché il talento è davvero, almeno in parte, un mistero sempre imprevedibile.
I paragoni tra le epoche sono sempre un po’ azzardati, ma la storia serve anche a questo. Eppure si sente affermare, di tanto in tanto, che i calciatori di oggi sarebbero “enciclopedie ambulanti” rispetto a quelli del passato, per conoscenze tattiche e movimenti introiettati specifici per ogni situazione. Forse in Italia siamo indietro anche per questo: siamo legati ancora agli schemi, mentre il calcio sta tornando più fluido. E non vorrei esagerare, perché il tourbillon di cambi di ruolo avveniva già con la grande Olanda, con la Russia anni Ottanta, e così via. I nostri calciatori però sembrano davvero legati al compitino. Spesso, per chi guarda la partita, si vede il tempo e la luce per un passaggio appena più complicato e verticale, ma il giocatore in questione (obbediente all’allenatore, o alla sua paura di sbagliare) finisce per optare per il solito giro palla orizzontale. Anche in letteratura, forse, abbiamo idealmente più risorse, ma ho l’impressione che tanti talenti siano addomesticati anche sulla pagina. Scrivono ciò che suggerisce il contesto, o ciò che del contesto loro hanno introiettato. Altro che azzardo nel paragonare giocatori di epoche diverse, qui vorrei confrontarmi con te su come i cambiamenti antropologici di cui abbiamo detto si riflettano anche sulla scrittura. Abbiamo troppi allenatori del talento letterario, troppi schemi? Io vengo anzitutto dalla scrittura che gioca quasi soltanto con passaggi in verticale, la poesia, ma anche nei tuoi romanzi ci sono slittamenti, a volte persino strappi che ti permettono di rilanciare la palla entro una partita che si fa diversa, che cambia ritmo. Com’eri, tu, con la palla al piede, e qual è stata la tua storia calcistica? E adesso come giochi la partita letteraria, rispetto agli schemi o ai moduli predominanti?
Che belle domande che mi fai Andrea! Beh, io ero quello che un tempo veniva definito fantasista, e che oggi verrebbe spostato sulla fascia destra o sinistra per non squilibrare la squadra (a quindici anni suscitai l’interesse del Pescara, che al tempo giocava in A). Avevo buon fisico e ottima tecnica, ero veloce e segnavo tanti gol, però mi piaceva dribblare e mi piaceva moltissimo l’assist – l’assist filtrante, azzardato, che “apre” il campo all’improvviso (un artista a tal proposito fu Michael Laudrup). Quello che, passando al gioco “serio” dei professionisti, non vedo quasi più. Se penso che dove giocava Pirlo, nella nostra nazionale, oggi gioca Locatelli, l’istinto (con rispetto parlando) è di spegnere la tv e dedicarmi… alla lettura. Cosa che spesso, tra l’altro, succede davvero. E a proposito di lettura, condivido la tua impressione – ed è diffusa – che un certo addomesticamento sia avvenuto anche lì. Gli scrittori, anzi gli intellettuali sono fin troppo prigionieri del sistema. È vero, si tratta d’un sistema “di gomma”, al quale rimbalza tutto addosso e dal quale è difficilissimo e forse impossibile affrancarsi completamente; però mi aspetterei un briciolo di coraggio in più. Gli intellettuali ufficiali poi, mi riferisco soprattutto a loro, lungi dal mettere il potere in discussione, si sono trasformati in suoi megafoni (penso alla recente esperienza della pandemia, ma non solo). In altri termini, diciamo più letterari, molti di loro si sono venduti l’anima. Penso tu ti riferissi in special modo al loro stile, o al contenuto delle loro storie; ma il mio discorso riguarda anche quell’ambito lì, ne è in un certo senso la premessa. Io pure, come te, vengo dalla poesia; ma a differenza tua l’ho praticata solo in gioventù. Mi ha lasciato però qualcosa, credo e spero, forse quegli slittamenti di senso di cui parli. Il mio idolo, per usare un termine infantile, è stato a lungo Rimbaud, non solo per il genio ma per il coraggio, l’intransigenza, la coerenza misteriosa della sua vita. Poi mi è passata. L’età. Adesso, a cinquant’anni, non riesco a pensare a Rimbaud senza un certo imbarazzo; imbarazzo rivolto, sia chiaro a me e non a lui; alle mie promesse mancate; alle mie piccole ma quotidiane viltà; ai miei continui compromessi; al mio stomaco pieno borghese. Eppure mi piace pensare che un qualche piccolo seme l’amore (ché era proprio amore) per il ragazzino di Charleville (questo Maradona, questo George Best ante litteram) me lo abbia lasciato: magari uno sguardo un po’ storno e un po’ obliquo; uno sguardo che è come un dribbling da strada, quelli strani che ti vengono d’istinto e non sai nemmeno tu come ti è uscito.

“E non sai nemmeno tu come ti è uscito”. Il punto è questo. Accade, e direi in generale nella vita, nell’attività lavorativa come nello sport, persino nella routine quotidiana, che ci si senta a un certo punto in uno stato di grazia. La disciplina dovrebbe favorire questo momento, ma resta qualcosa di imponderabile. E l’esaltazione che prende è indicibile. Io non ho avuto una carriera calcistica come la tua, ma avrei potuto averla. Anch’io fantasista o seconda punta, quella di movimento attorno al centravantone. Da bambino ai miei genitori non passava nemmeno per la testa di portarmi in una squadra: giocavo per strada, nei prati, in qualche campetto. Poi, per il calcio quasi mi facevo prete: sono entrato in seminario quando ho capito che lì avrei giocato a calcio quotidianamente. Quindi al liceo, sfuggito ai preti, un compagno ha visto come trattavo la palla con i piedi, in palestra, e mi ha invitato nella sua squadra, poi ho vissuto un altro anno nel Borgomanero, che si era preso il mio cartellino. Ma ormai era tardi, gli studi e una crisi adolescenziale mi hanno fatto desistere. Ma conosco anch’io quello stato di grazia che ti permette di compiere gesti innaturali con una naturalezza straordinaria. Da piccolo ero un esperto del colpo dello scorpione. Da grande amavo rovesciate e acrobazie di qualsiasi genere. Con un’ultima rovesciata ho chiuso a giugno di quest’anno la mia carriera: la rete mi è costata mesi di sofferenza, per un’ernia che si è fatta risentire. Ma un episodio mi viene in mente per spiegare questo stato di grazia, che per la prima volta avevo provato in modo prolungato. Erano due notti che non dormivo per scrivere il mio romanzo, ma il lunedì accettai comunque il calcetto con gli amici. Pensavo che avrei dormito in campo. A fine partita, invece, gli amici mi chiesero se mi ero dopato, per quanto avevo corso. Ho provato a spiegare loro che mi ero dopato con la scrittura, ma mi hanno mandato in un certo paese che puoi immaginare anche tu. Quindi, per me, ora, Addio al calcio, per dirla con Magrelli. Almeno quello praticato. Ma, a proposito di Magrelli, mi chiedo se tu abbia un’idea sulla ragione per cui lo sport in generale, e soprattutto il calcio, sia così tanto presente nella nostra vita e, in fondo, sia così poco rappresentato nella letteratura. A parte i classici come Soriano o i libri per ragazzi (i miei figli possiedono la collezione quasi completa delle “Cipolline” di Luigi Garlando), a me vengono in mente pochi titoli: Undici racconti sul calcio di Cela, 10 di Voltolini… Il calcio rimane come metafora o occasione anche per altri titoli (conosci Futbol bailado di Garlini?), ma non è mai preso di petto, come invece ha saputo fare, con il tennis, David Foster Wallace in Infinite Jest. In poesia non sarebbe difficile comporre un’antologia con versi sul calcio, da Saba a Sereni, da Raboni a Cucchi, ma siamo sempre all’immagine sintetica, allo sport come metafora della vita. Forse certi temi sono troppo popolari per essere affrontati letterariamente.
Anche a me accadde una crisi adolescenziale che mi impedì di provare più seriamente con il calcio… L’adolescenza è un tale casino, un tale serbatoio di energie spesso oscure. Ma io non avevo la testa, credo, del giocatore vero; non perché fossi indisciplinato ma perché ero molto umorale, tanto che al momento di fare le squadre certe volte gli amici mi chiedevano se fossi di luna buona o storta. E la luna buona, talora, si manifesta anche in letteratura. Non sappiamo perché, ma sappiamo che è. Il fenomeno può risultare sconvolgente, come credo tu sappia meglio di me, in ambito poetico, dove si può davvero sperimentare la sensazione straniante di una visita, di un ascolto, di un dialogo non si sa con chi. Ma pure in ambito narrativo ci raggiungono da un altrove – che Stephen King chiama il pozzo delle storie – immagini, suggestioni, sensazioni che contengono già in nuce il romanzo a venire. Ovviamente tutto ciò non può che concretizzarsi entro un quadro di forte disciplina. La disciplina è, sì, un metodo per affinare gli attrezzi del mestiere, ma è parimenti la predisposizione di un “campo di forze” in cui possano manifestarsi i piccoli miracoli della creatività. Come la fortuna, insomma, anche la musa bisogna cercarsela. In fondo calcio e scrittura non differiscono poi troppo, riflettendoci meglio; anzi io, sarà perché ho avuto la fortuna di praticarli entrambi con un minimo di abilità, li ho sempre ritenuti contigui, facce dello stesso enigmatico cubo di Rubik. Perciò ancor più mi stupisce ciò che fai giustamente notare, e cioè che non esistono molti romanzi a tema calcistico (no, non ho letto Garlini e lo cercherò). Manca un Infinite Jest calcistico, sì. Gli Americani per esempio hanno scritto anche parecchia roba sul baseball. Invece noi, che abbiamo trovato nel calcio una vera e propria religione laica, siamo fermi al mio romanzetto (ah ah ah) e poco altro. Bisogna rimediare!
Calcio e scrittura contigui: pensa che al convegno di giovani poeti che avevo organizzato a Borgomanero il momento culminante è stato proprio la partita a calcio! Era il settembre del 2001: bei tempi. Ora non siamo più giovani, come calciatori, ma forse siamo nella piena maturità di scrittori. Chi vorresti, come compagno di squadra, tra i narratori italiani tuoi coetanei? C’è qualcuno con cui ti senti in competizione? Parlo della sana competizione che aiuta a migliorarsi, pur nella differenza di stile, proprio come Sinner-Alcaraz. E chi vorresti, come allenatore, invece, tra i nostri maggiori narratori? Resterei in Italia, altrimenti immagino già diversi nomi stranieri che proporresti…
Dunque. Fra i narratori della mia generazione ce ne sono parecchi che stimo e che seguo. Quest’anno ho letto alcuni romanzi notevoli: quello di Deborah Gambetta, quello di Francesca Marzia Esposito, quello di Nicoletta Verna, quello di Andrea Pomella. Se dovessi però fare nomi “fissi”, di autori che leggo costantemente, citerei Sandro Campani e Cristò Chiapparino. Il primo è un po’ il mio opposto, e dunque gli invidio tutto ciò che io non ho: una “serietà” naturale (mentre io tendo a essere pop), uno stile sempre composto, una “difficoltà” che non ha nulla di voluto ma è consustanziale alla sua prosa, peraltro limpida. Il secondo è un grande affabulatore, dotato di una fantasia affascinante e di uno sguardo molto acuto sul tempo presente. Come allenatore invece, beh. È molto lontano da me – e forse da tutti – però ammiro Antonio Moresco, e credo che possa incarnare una delle poche figure credibili di “maestro” in un tempo che i maestri li uccide o, peggio, li ignora. Se dovessi scommettere su un nome che resisterà nel tempo, forse farei il suo. La sua opera, per tutta una serie di fattori che qui non posso elencare, mi sembra in un certo senso fuori dal tempo, e dunque potenzialmente eterna.
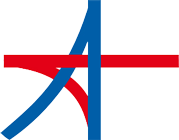
 Gratuito. Da Pexels.com
Gratuito. Da Pexels.com



 Marco Merlin
Marco Merlin



 gratuito, da Pexels.com
gratuito, da Pexels.com
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!