Il docente come ‘studente esperto’
Alcune riflessioni sulla scuola, in base alla mia personale esperienza, e sulle caratteristiche che dovrebbe avere una “scuola a tempo pieno”, senza compiti e impegni di studio da portare a termine dopo le lezioni.
Gli studenti di ieri e di oggi
Metà della mia vita è ormai stata spesa come insegnante, e l’altra metà è trascorsa comunque a scuola, nelle vesti di studente. Per queste ragioni, è scontato che reiteratamente mi si chieda se i ragazzi siano davvero cambiati, come pare, e se oggi insomma sono, come dire?, più “difficili” rispetto al passato. Tendo però a eludere una simile questione per varie ragioni. Anzitutto, diffido della memoria. I problemi attuali ci sembrano maggiori rispetto a quelli ormai rimossi, ma spesso è solo una questione di prospettiva – e di categorie diverse, certo, perché una volta si parlava di “impegno” e di “capacità” con troppa leggerezza, oggi conosciamo l’incidenza di una galassia (in continua espansione, peraltro) di “disturbi dell’apprendimento”, che non dipendono dal quoziente intellettivo (altro parametro da utilizzare comunque con cautela, pur non essendo io un sostenitore acritico delle “diverse forme di intelligenza”, nuovo paradigma problematico). Inoltre, la mia esperienza, per quanto ampia nel tempo, è limitata a una specifica realtà territoriale e circoscritta alle classi che ho avuto, con le mille variabili che ne hanno determinata la composizione. Non va trascurato il fatto di insegnare in una scuola paritaria, costretta a imporre una retta che non tutte le famiglie possono permettersi. Se si vuole un giudizio sensato, insomma, si cerchi di assumere una prospettiva corretta, secondo criteri più scientifici: sia dato spazio a esperti che ragionano con dati attendibili. Infine, tende sempre a insinuarsi, in questi discorsi generazionali, un pregiudizio negativo nei confronti dei giovani, anche soltanto perché non rispecchiano più i capisaldi di una società che è davvero mutata (dal mito del posto fisso alla pluralità di esperienze lavorative se non di mestieri compositi e difficili da definire; dall’ideale del sacrificio a quello della realizzazione di sé, anche a dispetto della carriera; dalla morale del senso di colpa, gestita verticalmente dai genitori, alla morale della vergogna tra pari, dal momento che gli adulti paiono, agli occhi dei giovani, sempre meno significativi, in particolare per la “scomparsa del padre” che la ridefinizione dei generi sta comportando; e così via). Il buon senso e l’esperienza suggeriscono che a vent’anni si è spontaneamente rivoluzionari, mentre a cinquanta si diventa conservatori: l’idea mi spaventa e perciò mi aggrappo alla cultura per contrastare, almeno in questo caso, la natura.
Tuttavia, pur restando ottimista rispetto alle generazioni venture, non posso negare alcune impressioni e prendere atto di determinati fatti, per cui, quando mi si pone la fatidica domanda, rispondo che i ragazzi di oggi non sono né più né meno ricchi di potenzialità rispetto a quelli del passato, ma forse sono davvero più fragili e più esposti a certi pericoli. Gli studenti entrano in crisi per un nulla, sono ansiosi e soffrono di ansia di prestazione. Non chiamerei in ballo ancora una volta il Covid: è un alibi troppo scontato. Il 2020 ha inciso soprattutto su una fascia di età che ho visto scorrere sui banchi, ma la fragilità che riscontro è un dato strutturale rilevabile su un arco di tempo più ampio.
Dal mio punto di vista, non mi sbilancio a sostenere che il problema sia imputabile solo ai giovani, a una loro reale mutazione antropologica. Secondo me, molto dipende dal contesto. Si sono perse strutture sociali che in qualche modo garantivano degli argini e contenevano il problema. Si potrebbe parlare genericamente di valori, di tradizioni o di ideologie e persino di religione; io qui sottolineerei il catalizzatore di tutti questi elementi: la famiglia. Lungi da me, ancora una volta, l’esaltazione del passato, con famiglie che dietro una facciata perbenista celavano malesseri profondi: c’è tanta letteratura disponibile sul tema. E, tuttavia, è chiaro che oggi, molto spesso (quando si generalizza, non si rende ragione della realtà particolare, con le eccezioni del caso), i ragazzi trovano nel contesto familiare un amplificatore delle loro ansie e delle loro fragilità. Le celebri vignette che confrontano un passato in cui il docente, in cattedra, veniva spalleggiato dai genitori, con il figlio nel ruolo di unico imputato davanti agli adulti per gli scarsi risultati ottenuti, a dispetto della vignetta in cui oggidì i genitori puntano il dito contro l’insegnante, con il bambino gongolante nel ruolo di accusatore, raccontano bene quanto, a dispetto delle difese retoriche, il ruolo sociale del docente sia decaduto. Ogni singolo, piccolo problema diventa (ancora una volta: molto spesso) una ferita familiare, un’offesa a cui rimediare prontamente. Quante volte arrivano al preside genitori infuriati e lesti a parlare di bullismo a fronte di semplici screzi infantili? Quante volte il docente (adulto laureato) viene smentito perché il genitore dà immediatamente credito alla versione dei fatti raccontati dal figlio, che non è detto sia per forza malizioso nel suo racconto, ma ha la capacità di interpretazione che può avere alla sua età?
Quando, una volta, un genitore non assecondava le rimostranze del ragazzo o della ragazza, non significa che non le capisse o non le ascoltasse. Nella risposta che ricevevo io, da bambino (addirittura preventiva, prima che fosse sorto davvero qualche caso) c’erano diversi impliciti. “Sappi che io non mi ci metto nei vostri affari da bambini, quindi vedi di arrangiarti. E fatti rispettare, mi raccomando” (al quale si aggiungeva il corollario: “Se l’insegnante ti dà la nota per qualcosa, vuol dire che te la meriti”): un simile messaggio serviva a relativizzare il mondo dei ragazzi e marcare il distacco dal mondo degli adulti. Significava, quindi, che nella vita ci sono problemi ben più seri e un bambino non deve credersi il centro del mondo. Non solo: significava anche che il genitore aveva fiducia nel fatto che tu, bambino, potevi cavartela anche da solo. Racchiudeva, insomma, sia un monito sia un messaggio di fiducia.
Al di là delle risposte emotive delle famiglie ai disagi del figlio o della figlia, è un dato di fatto che i ragazzi, oggi, vivono una vita più frenetica e ricca di esperienze, a partire dalla realtà senza filtri che entra nei loro smartphone o nei loro device per giungere alle esperienze che possono permettersi di vivere. (Se penso ai miei pomeriggi di noia nel cortile o nella brughiera, spesi a fantasticare o, anche, all’impossibilità di iscrivermi a una squadra di calcio giovanile, perché i miei non avevano tempo per gestirmi, percepisco davvero quanto il mondo sia cambiato. Per non parlare delle vacanze nella riviera romagnola: se non ci fossero state le “gite scolastiche”, sarei arrivato a vent’anni davvero con uno sguardo provinciale sul mondo). La sovraesposizione a molteplici sollecitazioni incide nel percorso di apprendimento dei giovani, perché coloro i quali trovano, per merito e per fortuna, le giuste chiavi per il successo scolastico hanno ancora maggiori possibilità di crescita, mentre chi incontra qualche difficoltà iniziale rischia di soccombere anzitempo. La scuola, sì, avrebbe ancora un alto compito di giustizia sociale, favorendo in modo più equo lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno.
Rispetto a queste condizioni sociali, azzarderei un’ipotesi, su cui mi piacerebbe interpellare gli esperti del caso. Ho l’impressione che i ragazzi di oggi abbiano una mente sempre più fluida. Il pensiero intuitivo sta soppiantando il ragionamento? (Vi invito a questo punto a leggere Daniel Kahneman, Pensieri lenti e veloci). Faccio da me la tara: se si ha a che fare con individui che stanno attraversando quella che si definisce per eccellenza l’età evolutiva è normale che si fatichi a registrare regolari progressi nella “solidificazione” dei concetti e dei ragionamenti. I ragazzi imparano e dimenticano rapidamente. E qui spesso scatta il gioco dello “scarica barile” tra livelli scolastici: alle “medie” ci si lamenta delle “elementari”, alle “superiori” delle “medie”, all’università delle “superiori”. Al di là di effettivi problemi (ah, se nella primaria invece di arrivare in modo improprio e meccanico all’analisi logica si limitassero alla scrittura e alla lettura…), io stesso mi stupisco di come alcuni concetti ampiamente sottolineati e ribaditi, dopo tre mesi estivi, evaporino come neve al sole. A questo punto, mi piacerebbe entrare nel merito di svariate attività specifiche che svolgo, quando per esempio avviamo l’attività didattica con “mappe mentali” su un argomento per giungere a costruire “mappe concettuali”, ma non è il caso. E resto sorpreso io per primo di come un lavoro tanto sistematico non dia i frutti sperati, almeno nell’immediato. Mi consolo sperando che il solco sia stato comunque scavato e, prima o poi, il pensiero, al momento opportuno, saprà in esso adagiarsi e solidificarsi.
Il passaggio dalla scuola “primaria” alla “secondaria”
Se questa è la scena, complessa e in movimento, occorre rilevare quanto anche la figura del docente sia in trasformazione. O dovrebbe essere. I principi didattici che rendono più autentico l’apprendimento sono dichiarati da decenni, ma non sembrano essere penetrati del tutto nella pratica didattica, rimasta immutata in molti presupposti. Forse nella scuola primaria e nella secondaria di primo grado qualche passo in avanti si è compiuto, ma nelle “scuole superiori”, con l’irrigidirsi di ogni singola disciplina, vince ancora la tradizione: il docente è un dispensatore del sapere che, attraverso la lezione frontale (non sia mai: meglio parlare di lezione “dialogata”, anche se è, nella sostanza, la stessa cosa), infonde la sua scienza negli uditori. I quali, insofferenti a una simile prassi e talvolta iperattivi con tanto di certificazione, esasperano la frustrazione del docente, sempre più vecchio al cospetto di generazioni sempre più “di nuovo conio”. Da qui, la lamentazione infinita rispetto ai giovani d’oggi e l’elogio dei tempi in cui si stava meglio anche quando si stava peggio.
Prima di procedere, mi permetto di chiarire il punto in cui inserisco la mia esperienza. Ho insegnato in tutti gli anni della Scuola Secondaria, quindi ho una visione dello spettro di problematiche che si affrontano con studenti dagli undici ai diciannove anni. Poi, però, ho deciso, all’interno del mio istituto, di dedicarmi alla “scuola media”. Qualcuno ogni tanto mi chiede come mai, considerando le mie attività letterarie: dovrei, ci si immagina, trovare maggiore gratificazione insegnando storia della letteratura italiana, anziché dedicarmi a ortografia e pensieri semplici frammisti a paturnie preadolescenziali di individui che muovono i primi incerti passi oltre il confine dell’infanzia. Ebbene, le ragioni della mia scelta sono varie, ma qui ne esplicito una, comunque fondamentale. Proprio perché all’ingresso ricevo studenti che in fondo sono ancora “bambini” ma, nell’arco di pochi mesi, li vedo trasformarsi in “ragazzi e ragazze”, le esperienze che ricadono in questa età sono decisive. L’impatto che può avere un docente in questa fase è determinante. Anche da un punto di vista educativo, direi che a quattordici anni i giochi sono ormai fatti. Sì, certo, l’adolescenza imperverserà durante i cinque anni della scuola superiore (e pure oltre: ricordiamo il concetto di “adolescenza sociale” o l’infelice epiteto di “bamboccioni” usato dal fu ministro Tommaso Padoa Schioppa), ma malgrado le sperimentazioni personali e le ribellioni che vivranno, i giovani alla fine torneranno sui valori e i principi che hanno introiettato in precedenza. Qualche crisi veramente profonda, tale da destrutturare una personalità in un’età maggiore, favorendo poi la costruzione di una nuova identità, resta un caso più raro e non augurabile.
Ma qui siamo quasi di fronte a un paradosso. Al cospetto dell’importanza di questa “età negata” (titolo di una vecchia ricerca sui preadolescenti), i risultati “didattici” restano spesso aleatori, anche a fronte di quella fluidità di pensiero di cui si è detto. Tanto impegno e pochi risultati, insomma. Si lavora per dissodare il terreno, per renderlo fertile alle esperienze di apprendimento che verranno in seguito.
Non si vuole esagerare, sia chiaro. Alcuni risultati tangibili si raggiungono già nella Scuola Secondaria di primo grado. Ma gli obiettivi principali di questo ordine scolastico sono altri e si riassumono nella funzione orientativa e nella capacità di far scoprire allo studente un metodo di studio personale e, quindi, efficace. Non a caso, il motto che spesso ripeto è che occorre puntare a una testa ben fatta, piuttosto che a una testa ben piena:
La prima finalità dell’insegnamento è stata formulata da Montaigne: è meglio una testa ben fatta che una testa ben piena. Cosa significa “una testa ben piena” è chiaro; è una testa nella quale il sapere è accumulato, ammucchiato, e non dispone di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso”. Una testa ben “fatta” significa che invece di accumulare il sapere è molto più importante disporre allo stesso tempo di: un’attitudine generale a porre e a trattare i problemi; principi organizzatori che permettano di collegare i saperi e di dare loro senso. (Edgar Morin)
Mi sembra che la citazione colga lo spirito di quel passaggio dalla “scuola primaria”, con alunni sostanzialmente privi di pensiero astratto e tendenzialmente esecutivi, alla “scuola secondaria”, dove si dovrebbe insegnare il pensiero critico. Dunque, nel “primo grado” della “Secondaria” occorre rompere certi meccanismi acritici che la prassi scolastica primaria genera e liberare il pensiero da schemi non più validi. Avrei molti esempi concreti. A partire dall’inveterata abitudine di far analizzare parola per parola anziché lavorare per sintagmi, che genera un’idea sbagliata dell’enunciato, per cui si fatica a capire come in una frase una parola svolga un ruolo in relazione alle altre parole e non una funzione fissa e invariabile (“Di, a, da, in, con, su, per, tra, fra”: chi non conosce la filastrocca delle preposizioni? Da qui il trauma dello studente che ha ricevuto tale imprinting quando scopre che “su” può essere un avverbio. Analogamente avviene per gli articoli omografi ai pronomi, e via esemplificando). Che fatica, non tanto spiegare, quanto far capire (ossia creare un concetto stabile al posto del precedente) che il soggetto non è sempre una persona e non precede obbligatoriamente il verbo. Così come il “complemento oggetto” non è detto sia un “oggetto” e può diventare un soggetto (passivo). Più volte ripeto ai miei studenti che la grammatica non è importante in sé: non troveranno lavoro se sanno analizzare correttamente un verbo (“No, transitare non è un verbo transitivo”…). La grammatica è importante perché può renderli liberi. Cominciamo a uscire dalla schiavitù della “linea” su cui si adagiano le parole e scopriremo che la poesia è lì a un passo, che ci attende.
Il cuore della “lezione” o, meglio, della situazione di apprendimento
L’importanza non tanto di “spiegare”, quanto di “far capire”, dicevamo. Eccoci di fronte al ruolo del docente. Spiegamo subito che l’insegnante migliore non è quello che ne sa di più, ma quello che sa intercettare l’alunno all’altezza del suo sapere e farlo crescere (Don Bosco ricordava in modo analogo che non basta amare i ragazzi, ma occorre che essi sentano di essere amati). E questo principio già distrugge il presupposto della lezione frontale, in cui il docente, concentrato sulla sua performance, non ha di fronte nessuno, poiché la classe è una proiezione della propria mente. La classe è come il pubblico: un mostro creato dall’immaginazione che ci trascina verso la retorica, sul baratro di due possibili abissi: il compiacimento oppure la frustrazione. Se la lezione frontale può avere un senso con ragazzi ormai formati o, in particolare, con adulti pienamente responsabili dei propri processi mentali, nella fase della “scuola media” perseverare nel mettere al centro della situazione di apprendimento il docente è dar credito a un incantamento. Il docente bravissimo che svolge la sua meravigliosa lezione che però non lascia il segno (come l’emozionantissimo film visto la sera prima, di cui non si è colto il senso e che, in definitiva, non ci ha cambiato), è vittima di un incantamento. Non si accorge della scena di cui è parte e si appiattisce sul suo ruolo, ancorato al suo punto di vista. È una parola che non entra in relazione con le altre.
Ho espresso l’idea in modo radicale, me ne rendo conto. Ma sono consapevole delle mille sfumature che si inseriscono rispetto agli estremi che sto delineando. Anzi, a dirla tutta, dovessi parlare di me stesso, mi definirei un “animale da lezione frontale”. Nella mia esperienza, non ho avuto particolari difficoltà nel gestire anche le classi più agitate e ho dimostrato più volte di essere ben consapevole (come ogni docente, del resto) degli alunni che stanno veramente ascoltando e capendo, mentre spiego, e quelli che non si accorgono nemmeno di non capire. La classe è sempre un insieme di individui, per l’occhio allenato. E sono altrettanto consapevole che quando si parla di strategie didattiche queste ultime non esistono mai in modo puro. Si mescolano continuamente, e direi proficuamente, nel migliore dei casi. Anche ora, ritengo che in alcuni momenti sia importante un impatto frontale con il gruppo, così come so che, mentre procedo con una spiegazione per tutti, in realtà sto concedendo una pausa a qualcuno che non è in grado di capire e a cui mi dedicherò di lì a poco, in un’altra attività. E così via. Ma di difensori di visioni tradizionali della scuola e della funzione del docente, che ottengono ovvi plausi da una società sempre più gerontocratica, ce ne sono troppi, per cui non mi soffermerò ulteriormente nell’esplicitare quanto di buono va preservato dalla tradizione. C’è chi continuerà a mettere al centro dell’apprendimento il valore della disciplina in sé (per esempio la scrittrice Paola Mastrocola, se ho ben capito il senso di alcuni suoi interventi sul tema) oppure la figura del docente (per esempio il filosofo Massimo Recalcati, autore del libro L’ora di lezione, significativamente sottotitolato Per un’erotica dell’insegnamento). E mi guarderei bene dal pensare che i contenuti non siano fondamentali nel generare la forma stessa della mente oppure che il carisma del docente non incida (anzi, ricordiamo che parliamo di “insegnanti” proprio perché dovrebbero “lasciare il segno”, ovvero essere adulti significativi agli occhi degli alunni). Né oserei mettere al centro della lezione l’alunno in sé, già così difeso nel suo naturale egocentrismo dalla famiglia. Al centro della situazione di apprendimento va posta la “relazione”; anzi, il “sistema di relazioni” che di volta in volta si attiva tra tutti i protagonisti della scena: l’alunno, i compagni di classe, il docente, la materia. E persino ciò che preme intorno all’aula: dalla famiglia all’intero ambiente scolastico, dalla società alla stessa storia che, malgrado tutto, determina la vita della classe, a volte in modo violentemente diretto, a volte in modo subdolo (con buona pace delle ottime pratiche scolastiche abituali che si svolgono solo in classe, come riti separati dalla vita).
Se tale visione non è del tutto errata, si capisce quanto sia complessa la situazione entro cui il docente cerca di attivare una situazione di apprendimento autentica, quindi efficace.
La scuola a tempo pieno: un progetto
Nella mia carriera scolastica, ho sempre inseguito le buone pratiche che mi si rivelavano utili, senza smettere di sperimentare. Di scoperta in scoperta (spesso i corsi di formazione si rivelavano dispensatori di indicazioni teoriche non utili per i concreti problemi didattici di ogni materia), ho elaborato un particolare approccio alla grammatica e, all’interno del mio istituto, siamo arrivati a definire un metodo didattico specifico per una sezione (ne ho parlato qui). Per l’anno prossimo, adesso, siamo pronti a compiere l’ultima evoluzione e, se otterremo il riscontro delle iscrizioni, avvieremo una sezione “a tempo pieno”, con quaranta ore di scuola, ma che garantirà agli studenti di aver completato ogni attività. Terminata la scuola alle 16.00, insomma, non avranno né compiti né incombenze di studio.
Provo a raccontare qui i principi che guidano questo progetto.
Uno dei capisaldi della precedente esperienza è il rigetto dei “compiti a casa”. Non si trattava di una scelta a servizio delle famiglie, per pura accondiscendenza. La scelta era dettata da una duplice motivazione. Anzitutto, l’accoglimento dei dati di fatto: pretendere che i ragazzi, peraltro iperimpegnati in molti casi ben oltre le attività scolastiche, avessero le energie mentali per dedicarsi, nel tardo pomeriggio o di sera, all’esecuzione dei compiti, ci sembrava un’utopia. In ogni caso, anche di fronte a compiti “sostenibili”, malgrado le raccomandazioni teoriche (prima si studia e si ripassa, poi si svolgono gli esercizi), quanti ragazzi espletavano i loro doveri in modo corretto? A parte lo stress (l’esposizione al quale, secondo alcuni, mantiene un valore formativo) che generavano, all’interno di un contesto familiare spesso già stressato per altri fattori, anche coloro i quali non si limitavano a copiarli da un compagno o a farli eseguire dall’intelligenza artificiale, finivano per risolvere ogni problema attraverso una prassi tossica, quanto efficace. Un solo esempio: il testo, magari in inglese, da leggere per poi rispondere alle domande. Quanti studenti prima avranno, di fronte a un simile compito, letto il testo e solo in seguito, senza scansionare il testo, avranno risposto, “con parole loro”, ai quesiti? L’esperienza insegna. La scuola li ha addestrati alla massima efficacia: le domande sono conseguenziali e la prima si riferisce alla prima parte del testo, la seconda a una sequenza successiva, e così via. Basterà guardare le parole della domanda, ritrovarle nel testo, copiare le frasi in inglese pertinenti. Un’attività di comprensione è stata riportata alla meccanicità di un processo, che si è consolidato anno dopo anno, fin dai primi momenti. Ma non basta. Al di là di ciò, è l’idea stessa che lo studente debba affrontare da solo l’esercizio, senza il supporto dell’esperto, che è sbagliata. Il passaggio dalla teoria alla pratica è il più delicato, lì si controlla e si insegna il ragionamento. Conoscere la definizione del soggetto è importante, ma il problema è smontare correttamente l’enunciato e scovare il soggetto senza cadere nei tranelli dell’esempio e negli automatismi su cui si adagia il pensiero (veloce). Certo, nella situazione tradizionale al lavoro individuale segue poi la correzione in classe, che, però, e lo sappiamo bene, viene vissuta con scarsa attenzione e sempre in una logica collettiva. Pochi sono gli alunni che, di fronte a un errore, sanno intervenire e chiedere spiegazioni, perché consapevoli del ragionamento che hanno seguito e così presenti a sé stessi e così motivati da volerlo correggere. Giorno dopo giorno vince la pigrizia, imposta dalla consuetudine. A fronte di queste motivazioni, infatti, da tempo abbiamo optato per la classe rovesciata: a casa ci si prepara (magari memorizzando la definizione di soggetto) e insieme al docente, in classe, ci si esercita (anche in questo caso, con strategie, da parte dell’insegnante, tese a evitare l’esecuzione collettiva dell’esercizio).
Ora, con l’idea di una scuola a tempo pieno, si compie l’ultimo passo e si arriva a reintrodurre nella lezione (meglio: nella situazione di apprendimento) anche la fase dello studio, gestita come illustreremo in seguito.
Per esprimere il significato di tale evoluzione ricorro a una similitudine: è come creare uno spazio unico laddove prima vi erano tre ambienti separati.

Nel caso in cui la lezione, lo studio e i compiti sono situazioni separate, si presume che lo studente sia in grado di viverle in modo armonico. Intanto, bisognerebbe affrontare il problema della gestione del tempo – e qui torniamo alla vita impegnata di molti ragazzi di oggi. Nel nostro istituto, l’utilizzo di un Calendar di classe serve non solo per la pianificazione degli studenti, ma soprattutto per controllare il carico di lavoro assegnato dai docenti. Ipotizziamo pure che tale problema sia risolto, anche se è facile immaginare che persino un’ottima pianificazione da parte dei docenti e da parte dello studente comporti comunque momenti di lavoro personale nel tardo pomeriggio, o addirittura di sera: ne siamo consapevoli? Lo riteniamo giusto o, come sosterrebbero gli educatori più severi, “formativo”? Stiamo ragionando per principi oppure abbiamo realmente innanzi agli occhi i nostri studenti? Resta il problema degli ambienti: dove e in quali condizioni gli alunni studiano e svolgono i compiti? Molti istituti, compreso il nostro, offrono tempi e spazi per chi si ferma nel pomeriggio; per chi esce dalla scuola, ci si affida alla famiglia e si presume che a casa tutti abbiano spazi adatti e un’assistenza congrua (ma qui riecheggia in sottofondo ancora la voce dell’educatore severo, che pretende che i ragazzi si arrangino e si assumano le loro responsabilità, a prescindere dalle condizioni socio-economiche e personali dell’individuo…). È facile capire che un contesto simile è pensato per l’alunno ideale, non per quello fragile, demotivato, incapace di organizzarsi, con un supporto familiare magari non adeguato, magari con problemi specifici di apprendimento o, anche, privo di strategie di studio. In questo caso l’esperto, ovvero il docente, demanda ad altri la soluzione del problema. Ovviamente, in classe cercherà poi di analizzare la situazione e di porre rimedio, ma a partire da dati incerti. Per restare alla nostra metafora dell’ambiente: che cosa sa, il docente, di quello che accade nelle altre stanze?

E come può intervenire su ciò che avviene al di là della parete, fuori del suo controllo? Le immagini a destra propongono lo spazio open space in cui il momento di apprendimento si integra con lo studio e con lo svolgimento degli esercizi necessari per verificare la comprensione e lo sviluppo delle competenze, a partire dalle conoscenze acquisite. È facile intuire come, nel secondo caso, il docente valuti anche l’impegno e curi il metodo di lavoro di ciascuno, non con indicazioni teoriche, ma in modo pratico e personalizzato, gomito a gomito con l’alunno.
Possibili perplessità
Ogni nuova situazione comporta comunque nuovi problemi, per cui non si crede di aver trovato la soluzione perfetta. E, come accennato, il peso della tradizione incombe. Quali perplessità genera il nuovo scenario nei docenti, nelle famiglie e negli studenti?
Il docente dovrà essere in grado di gestire una classe suddivisa in gruppi che svolgono attività diverse. Nel mio istituto partiamo avvantaggiati, perché il setting delle aule propone isole di lavoro: la cooperazione è una prassi costante. Va da sé che non è semplice mantenere un clima di lavoro efficiente e disciplinato: l’insegnante impreparato, abituato alla lezione frontale, avrà la sensazione di perdere il controllo. Ma, come detto, il controllo implicito nella lezione frontale è in verità repressivo e i vantaggi di una situazione di apprendimento in cui lo studente è attivo sono ben noti. Ricordiamo, di passaggio, il cono dell’apprendimento:

Per un docente doversi occupare anche degli esercizi e dello studio significa riappropriarsi pienamente del suo ruolo, e non limitarsi a essere un brillante esperto che intrattiene il pubblico. Il docente torna a essere uno “studente esperto”, che affianca gli alunni durante l’attività. È fondamentale, infatti, che durante l’assimilazione dei contenuti e l’esecuzione degli esercizi mantenga un ruolo attivo, e non di semplice sorvegliante teso a curare la disciplina (anche se, come vedremo, in taluni momenti giocherà anche questo ruolo). In particolare nel delicato passaggio dalla “Primaria” alla “Secondaria”, il docente della “media” deve preoccuparsi delle capacità e delle modalità di assimilazione di ciascun alunno della sua classe. Accorgersi che uno studente non riesce a memorizzare una piccola sequenza di parole o una procedura non basta, occorre aiutarlo a trovare delle soluzioni. Nella prassi tradizionale c’è il rischio di limitarsi a fornire suggerimenti astratti che poi lo studente dovrebbe saper mettere in pratica da solo (o con un genitore inesperto che segue le proprie abitudini), per poi colpelizzarlo per la mancanza di impegno. In classe, invece, il docente ha la possibilità (non è detto che ci riesca, ma almeno ne ha l’opportunità) di controllare l’impegno e eventualmente di stimolarlo, di accorgersi di una difficoltà di apprendimento e di intervenire con precisione, sperimentando e provando soluzioni fino a scovare quella adeguata.
Immagino però la grande perplessità che il docente proietterà su questo scenario: se lo studente si trova anche ad assimilare i contenuti e a verificare con i compiti la propria comprensione in un contesto di classe, quando imparerà a concentrarsi, a studiare da solo, a responsabilizzarsi? La risposta potrebbe essere tranciante: alle scuole superiori, dopo che avrà imparato davvero un metodo personale e rafforzato la propria autostima. Ma vorrei sviscerare meglio la questione e smascherare alcuni pregiudizi.
Intanto, l’organizzazione delle attività in classe pertiene al docente, il quale affronterà di volta in volta i problemi riscontrati. Se vuole verificare la capacità di lavoro individuale di un alunno, basterà organizzarsi di conseguenza. Il lavoro individuale, anche silenzioso, non è escluso, può essere richiesto in determinati momenti. Nei modelli base che proporrò in seguito, anzi, è già previsto. Si ricordi inoltre che qualche studente potrebbe optare di lavorare da solo, oppure essere invitato a farlo perché manca dei prerequisiti per stare in gruppo (disturba, non lavora in modo proficuo, sfrutta le competenze altrui senza elaborarne di proprie, e così via). La responsabilità viene messa in pratica: lo studente “deve rispondere a qualcuno” (e in questo caso all’esperto, ovvero al docente) del suo lavoro e dei suoi risultati, senza per questo essere abbandonato alle proprie difficoltà. Non si può presumere che un ragazzo diventi responsabile senza prima avergli fornito le risorse necessarie in termini di consapevolezza di sé, di conoscenze e di abilità.
Il vero pregiudizio da vincere è però l’immagine stessa che abbiamo noi occidentali dello studio. Per noi studiare significa isolarsi dal mondo, in totale silenzio, concentrati sulla pagina letta mentalmente, fino a spalancare il nostro spirito alla comprensione. Solo successivamente potremo esercitarci nella ripetizione, più o meno libera, dei contenuti assimilati. Ebbene, studiare non è solo questo. Al di là dei molti processi implicati anche in questo modello, per nulla scontati e che, ancora una volta, il docente dovrebbe insegnare e verificare (saper svolgere le diverse tipologie di lettura necessarie; trovare le parole chiave; sottolineare a diversi livelli e prendere annotazioni; schematizzare; memorizzare; riassumere; parafrasare; approfondire; collegare ad altri argomenti noti; preparare materiali per lo studio o l’esposizione; ecc. ecc.), l’apprendimento, come ricordato dalla piramide sopra esposta, si rafforza quando usiamo interamente il nostro corpo.
C’è una scena del film Train de vie in cui, durante una riunione segreta fra il rabbino e gli uomini del villaggio, chiamati a trovare una soluzione di fronte all’incombere della minaccia nazista, la donna di casa scende autoritaria a imporre silenzio, perché i bambini sono appena andati a letto. Di fronte alle proteste dell’assemblea, intenta a ragionare su un grave problema, la donna ribadisce che a quel punto si deve pensare in silenzio. “Pensare in silenzio?! Ma come si fa?”, si chiedono smarriti gli uomini.
Nella tradizione ebraica, lo studio attraverso l’attività di coppia (ma l’hevruta in questo caso è ben più che un semplice compagno di studio) non va assimilato completamente alla nostra “peer-education”. Non si tratta di affiancare uno studente con un suo pari età ma con conoscenze o abilità superiori, affinché le trasmetta al compagno (soluzione che va adottata con molti accorgimenti, per non creare stereotipi e ruoli nel gruppo, per non attribuire responsabilità agli studenti che non competono loro, per non irrigidire “quello bravo” in un’immagine compiaciuta di sé). Il lavoro di coppia nella tradizione ebraica comporta la discussione ad alta voce, il dibattito, persino la gestualità, e la capacità di giocare il ruolo di chi sostiene la tesi opposta (qui, ci avviciniamo al debate, che solitamente però applichiamo a gruppi ampi, con varie complicazioni). Siamo dunque nella parte bassa del cono dell’apprendimento, con lo studente chiamato a essere attivo.
Ecco alcuni passaggi dal romanzo di Eran Katz Jerome diventa un genio. Il segreto dell’intelligenza, quando il protagonista vuole indagare per scoprire il segreto dello studio nelle yeshiva:
Continuammo a salire fino al terzo piano. Lì l’aula era affollata da altri studenti immersi nello studio. Avanzammo tra la folla e continuammo la nostra ascesa. Al piano più alto, alla fine del corridoio, quando pensavamo di aver visto l’intero palazzo, il rabbino Aaronson aprì una porticina che nascondeva un’aula ancora più grande di quelle che avevamo visto ai piani inferiori, affollata da più di duecento studenti, le cui chiacchiere facevano un rumore assordante. […]
Ancora una volta ci ritrovammo a farci largo attraverso una folla rumorosa, fino a raggiungere un angolo. C’erano studenti seduti, altri in piedi, altri che camminavano, e alcuni addirittura che litigavano. Non lontano da noi c’era uno studente dai capelli rossi con il volto paonazzo per lo sforzo, la rabbia, il trasporto o tutte e tre le cose insieme: agitava i pugni e calciava con le gambe, e allo stesso tempo dondolava febbrilmente avanti e indietro. Di fronte a lui c’era un altro ragazzo, molto più alto, con degli occhiali piuttosto eleganti dalla montatura cromata e una rada barbetta adolescenziale impegnata in una lotta senza quartiere per riuscire a esplodere dalla sua faccia congestionata. Ascoltava pazientemente il rosso, ogni tanto faceva un cenno di disaccordo, fino a che non arrivava il suo turno e questa volta era lui a battere con una mano sul tavolo agitando l’altra minacciosamente per aria. L’intero luogo sembrava esplodere dal rumore, e se non avessi saputo bene dove mi trovavo avrei detto che eravamo finiti alla borsa di New York.
Jerome si chinò verso il rabbino Dahari e fece una domanda ovvia: “Ma riescono davvero a imparare qualcosa, in questo putiferio?”.
Il rabbino Dahari incrociò le braccia e annuì. “Non solo sono in grado di imparare ‘nonostante’ il rumore, addirittura studiano meglio qui che in qualsiasi altro luogo del mondo! Volevi imparare il segreto di chi studia in una yeshiva? Eccolo qua. È questa la tecnica straordinaria che nessun’altra scuola al mondo ha mai osato provare. Fuoco e zolfo. Un pandemonio di rumore. Quando si entra a farne parte, non si sfugge. Ci si immerge in esso completamente”.
Noi occidentali siamo abituati a uno studio disincarnato e non condiviso con un compagno, eppure l’idea di educazione non è distante dai principi di studio ebraici. Continua il romanzo:
“Socrate, che per quel che ne so doveva essere entrato in contatto con questo metodo ebraico, parlava di come la testa di uno studente non possa riempirsi di informazioni solo perché un insegnante o qualcun altro gliele vuole insegnare. La conoscenza si accumula, e l’intelletto si sviluppa solo se lo studente elabora le informazioni per conto suo. In altre parole, Socrate riteneva che il ruolo di un educatore fosse quello di mettere lo studente in grado di pensare alle cose da solo, attraverso un processo di autorichiesta. La parola ‘EDUCAZIONE’ viene in fin dei conti dal latino ‘EDUCARE’, che significa ‘tirare fuori’. L’educatore pone delle domande in modo tale da spingere lo studente a ragionare, a ricercare, a proporre le sue idee e possibilità. In questo modo, lo studente arriverà a delle sue conclusioni. Una volta che lo studente si sarà reso conto del fatto che queste idee e conclusioni sono frutto della sua mente e non di quella dell’insegnante, è più facile che gli restino in testa. Con un hevruta accanto a ciascuno diventa l’‘educatore neutro’ dell’altro, e ciascuno riesce a stimolare i migliori pensieri e le migliori idee dell’altro” spiegò Itamar.
Anziché ridurre i nostri sensi (anestetizzarli) dovremmo amplificarli:
Nelle scuole normali, gli studenti se ne stanno seduti tranquilli in classe ad ascoltare l’insegnante, o in biblioteca a consultare libri e documenti. Nella yeshiva, gli studenti “erompono” ed “esplodono”, durante il processo di apprendimento della Torah. Usano tutta la loro energia, impegnando tutti gli organi del corpo, e soprattutto: parlano ad alta voce! Devi dire tu stesso a voce alta quello che si sta imparando. Una volta mi hanno detto che dicendo quello che si sta imparando, si attivano entrambe le zone del cervello e si migliorano la ricettività, la concentrazione e la memoria.
Ed è un dato di fatto che muovendosi aumenta il flusso di ossigeno al cervello. Dobbiamo accorgerci che impariamo non solo con il nostro cervello e con un’attenzione selettiva, ma con tutto il corpo. Noi occidentali siamo vittime di un’idea spiritualizzata, platonica, dell’apprendimento. Riduciamo l’uomo a individuo, quando è in sé stesso un “essere-in-relazione”. Il rischio è di creare studenti anestetizzati di fronte ad argomenti sempre più astratti. Ma il sapere senza sapore, la parola che non viene pronunciata, la conoscenza che non si fa vita se non nella nostra immaginazione (quando ne abbiamo le capacità!), non è pietanza che attira gli studenti – se non, ancora una volta, i pochi che partono da situazioni di vantaggio, e hanno come obiettivo la loro realizzazione individuale “a prescindere” degli altri.
Un’ultima difficoltà per i docenti sarà di dover abbattere anche qualche parete che segna il confine tra le diverse materie. Il nuovo assetto orario di quaranta ore prevederà infatti l’aumento di moduli per alcune materie: e le altre? Oltre ai modelli predisposti per la gestione dell’attività in classe, che integrano le attività di studio e di esercitazione, dovrebbe aumentare la corresponsabilità dei docenti nei confronti di tutte le materie e del carico di lavoro realmente sottoposto agli studenti. Si ipotizza, a mo’ di esempio, che il docente di italiano si occupi anche dello studio di un argomento di Arte o di Musica, all’occorrenza.
I genitori di fronte a una scuola a tempo pieno reagiranno invece in due modi opposti. Qualcuno si sentirà semplicemente sollevato, lieto di demandare completamente all’istituzione scolastica la formazione intellettuale del figlio o della figlia. Ma non escludo che ci siano genitori preoccupati per l’improvvisa autonomia che guadagneranno i figli al loro cospetto. Le ansie e le aspettative aumenteranno, in considerazione della perdita di controllo dei genitori. “Mio figlio, ce la farà, senza di me? Forse è meglio che io svolga la mia parte nel suo apprendimento: del resto, chi lo conosce meglio di me? Come potrà il docente, che deve dedicarsi a tanti alunni, concentrarsi davvero sui suoi bisogni specifici?” Anche qui, la risposta potrebbe essere tranciante: negli anni della “scuola media” lo studente deve conquistarsi la propria autonomia e, durante le scuole superiori, il genitore non riuscirà più a seguirlo. Ma, replicando anche alla prima ipotesi, ricorderei che la famiglia non perde il proprio ruolo, ma lo svolge in nuove modalità. Intanto, nella vita non si apprende solo a scuola, ma in ogni situazione. I genitori svolgono un ruolo di raccordo tra le varie esperienze dei figli (non solo la scuola, dunque, ma anche le attività sportive, i vari corsi frequentati, persino le libere attività individuali o con gli amici) affinché si armonizzino con i valori e la visione della vita che sta alla base della famiglia stessa. Il fatto poi di non avere compiti non significa che lo studente non possa avvantaggiarsi di un rinforzo, in caso di necessità, e ricavare nei pomeriggi o nei fine settimana ulteriori momenti di lavoro davvero personalizzati. Ma è auspicabile che il ruolo della famiglia rispetto alla scuola sia diverso. I genitori, di fronte al figlio responsabilizzato a definire a scuola la propria identità (come studente, ma anche come persona), dovrebbe limitarsi a stimolare la riflessione del figlio, chiedendogli di raccontare le sue esperienze, di gioire dei suoi successi e ancor più del superamento delle difficoltà, di esprimere il proprio punto di vista sulle attività svolte, sulle scelte del docente, sulle impostazioni metodologiche. Si tratterebbe, insomma, di collaborare nello sviluppo di doti metacognitive.
E gli studenti, quali perplessità potranno sollevare? In attesa di un riscontro effettivo, comincio col raccontare che il progetto, spiegato ai miei studenti, è piaciuto moltissimo. L’idea di non dover lavorare oltre le ore di scuola ha generato entusiasmo, anche se probabilmente non è stato ben compreso che ciò non deve significare una diminuzione dell’impegno e della fatica, ma un’ottimizzazione delle attività. Diventerà insomma ancor più necessario non perdere tempo in classe e lavorare in modo proficuo, stimolati magari dalla personalizzazione dei percorsi che questo impianto didattico presuppone. Ma, nel mio caso, gli studenti sono già abbastanza abituati a tali richieste, per le scelte adottate a suo tempo nella sezione, e quindi sono abbastanza consapevoli.
C’è una tipologia di studenti che si immagina più adatta all’impostazione didattica descritta? Nel nostro istituto siamo attenti a differenziare le proposte delle diverse sezioni sulla base dello stile di apprendimento – per quanto sia possibile identificarlo con precisione e al netto della libertà della famiglia di scegliere, anche al di là dei suggerimenti ricevuti. Se per la sezione “linguistica” è facile intuire la tipologia di studenti a cui consigliare questo potenziamento, per la sezione che segue un impianto didattico più tradizionale riteniamo più adatti gli alunni con uno stile cognitivo sistematico, analitico e verbale. Per la sezione “digitale” che ora diventerà “a tempo pieno” individuiamo lo stile cognitivo prevalente come intuitivo, globale e visuale. Ma sarà importante, con l’organizzazione dell’attività didattica che comprenderà anche il lavoro di norma lasciato al singolo studente nei momenti extra-didattici, rilevare nel ragazzo la capacità di seguire le indicazioni (che diventerà, man mano, una richiesta sempre maggiore di autonomia, pur nell’ambito di fasi di lavoro predisposte dal docente) e la predisposizione alla collaborazione. Per esempio, se si dovessero valutare casi di bisogni educativi speciali, un alunno con dislessia o disortografia potrebbe trovare nella sezione strumenti già predisposti per compensare le sue problematiche, mentre un alunno Adhd potrebbe risultare troppo distratto da alcuni strumenti (il PC) e dalla differenziazione del lavoro in classe, pronta a trasformarsi in un’officina in cui si svolgono diverse attività. Ma sappiamo che tali sigle sono sempre piuttosto generiche e ogni caso andrà valutato singolarmente.
Il design dell’attività in classe
Rispetto al design dell’attività di apprendimento, sintetizzo quanto già annotato in questo articolo, integrando il quadro con il nuovo impianto da “scuola a tempo pieno”.
Il superamento della lezione frontale, la necessità di mantenere attivi gli studenti e di includere lo studio e l’esercitazione nella “lezione” comportano anche la personalizzazione dei percorsi (sia con fasi di approfondimento o di accelerazione rispetto al “programma” sia con fasi di recupero e potenziamento in itinere), favorita dall’adozione degli strumenti digitali. Tra l’altro, legando il PC all’attività in classe, si supererà anche il problema dell’eventuale abuso dello strumento: lo studente a casa non ha la scusa del compito per utilizzare il computer, magari in modo inappropriato.
I modelli principali per l’esperienza didattica sono tre. Ovviamente, il docente sarà libero di inventarne altri, a seconda della propria competenza, degli obiettivi di apprendimento, dei bisogni rilevati, dell’argomento specifico.
Il primo modello prevede l’assegnazione di compiti a ogni piccolo gruppo di lavoro (tre, quattro studenti preferibilmente). Si tratterà di lavori differenti oppure del medesimo impegno, per esempio studiare un argomento nuovo (anche da soli, oppure prevedendo una seconda fase di confronto reciproco) oppure si tratterà di svolgere esercizi su qualcosa di nuovo o, ancora, affrontare specifiche attività di innesco, preparatorie alla vera e propria fase di apprendimento. Il docente, in questo caso, si siederà di volta in volta in un’isola di lavoro differente e, a seconda della situazione, svolgerà la sua lezione a pochi studenti, adeguandosi alle loro esigenze. Magari, quando raggiungerà un gruppo che ha appena affrontato da solo l’argomento, si accorgerà che il suo intervento è inutile e si limiterà al controllo, alla restituzione di un feedback positivo, oppure all’assegnazione di obiettivi e compiti più sfidanti. Potrebbe invece giungere in un gruppo che sta svolgendo esercizi e partire dalle difficoltà o dalle intuizioni pratiche per agganciare la parte teorica, se è bravo favorendo la scoperta di una regola o di un principio da parte degli studenti. E così via.
Il secondo modello è una variante in cui il primo gruppo con cui ha lavorato il docente sia formato perché ciascun suo componente raggiunga gli altri gruppi e trasmetta le conoscenze acquisite. Sarebbe utile che il docente insegnasse anche piccoli trucchi, tecniche specifiche, pratiche efficaci che gli alunni dovranno a loro volta applicare, per risultare efficaci nella spiegazione ai compagni.
Il terzo modello (Jigsaw method) consiste nell’assegnare a ogni studente di un’isola di lavoro una porzione dell’argomento che si andrà ad affrontare. Si inizierà con una fase di lavoro individuale (ecco che si recupera lo studio silenzioso), in cui lo studente sarà invitato a annotarsi dubbi e problemi, ma senza richiedere il supporto del docente (concentrato semmai a monitorare le corrette attività di studio: sottolineatura del testo, creazione di schemi, ecc.). Si procederà poi con la costituzione del “gruppo degli esperti”, in cui si confronteranno gli studenti che hanno studiato la medesima porzione dell’argomento generale. Qui, collaborando, cercheranno di risolvere ogni dubbio e di predisporre gli strumenti adeguati per la successiva fase di esposizione ai compagni, ma potranno, all’occorrenza, chiedere supporti al docente per risolvere qualsiasi dubbio. Infine, verranno ricomposte le isole e ciascun componente spiegherà ai compagni la parte studiata.
Immaginiamo la perplessità dell’insegnante privato del suo privilegio, ovvero di spiegare in modo ottimale, per tutti, la materia che governa con piena maestria. Ricordiamoci che al centro dell’apprendimento non si pone la performance del docente, ma la relazione, che favorisce lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno. La paura di non avere ogni aspetto dell’esperienza in classe sotto controllo (“Chissà come quell’alunno avrà spiegato male…”), permettetemi di annunciarlo, si rovescerà ben presto in un senso di benessere, perché si sarà sradicata una forma di ansia che attecchisce in una percezione errata della realtà. Fate la prova. Somministrate la vostra migliore lezione frontale alla classe, poi valutate ogni alunno, per misurare l’impoverimento dei concetti espressi, l’inadeguatezza linguistica, l’impossibilità di agganciare varie suggestioni, pur buone, in un’argomentazione che pure, nella vostra testa, era così salda…
Non più protagonista, ma regista della situazione di apprendimento, il docente resta tuttavia il responsabile dell’attività organizzata. Sarà suo compito dare indicazioni precise, tenere i tempi, fare in modo che, per quanto divertente e giocoso (specialmente all’inizio, ma poi crescendo i ragazzi diverranno naturalmente più seri e responsabili), il lavoro coordinato sia efficace. Potrà per esempio chiedere la restituzione di appunti, predisporre una verifica immediata (magari formativa), valutare uno o più gruppi sulla base dell’osservazione e con una rubrica nota agli studenti o quant’altro riterrà opportuno.
Sulla scelta del PC come strumento primario per tale didattica, si è detto. Attraverso il computer sarà possibile diversificare, in un’ottica pienamente inclusiva, i materiali forniti (videolezioni, slide, mappe concettuali, audio, schemi, risorse già presenti nel web…), approfondire o accelerare il percorso degli studenti più preparati, sostenere quelli che necessitano di rinforzare le basi, e così via. Ma l’ideale sarebbe disporre anche di una biblioteca di classe, per ricorrere spesso a libri, anche diversi, e continuare tutte le buone prassi, anche molto tradizionali, che permettono di “materializzare” i contenuti digitali (scrivendo sul quaderno, per esempio). In questi anni, nelle classi “digitali” si sono svolte attività specifiche per compensare l’uso meno continuativo del manuale, per esempio attraverso la stampa di testi di studio da manipolare (sottolineando, annotando a margine, ecc.), oppure con il lavoro su PC per la trasformazione di un testo grezzo in un testo organizzato con titoli, parole chiave evidenziate, inserimento di note e magari anche di altri apparati, come schede di approfondimento. Ma si sono consolidate anche attività che prevedono la trasformazione di una mappa concettuale preparata dal docente in un testo ben più completo (procedendo in direzione opposta dunque, rispetto a chi da un testo ampio ricava la struttura essenziale), oppure esercizi oculari, utili per velocizzare la lettura per chi ha già buone abilità ma anche e, soprattutto, migliorare la situazione di chi soffre di dislessia (in generale l’esercizio serve a tutti per allenare la concentrazione). Ricorderei anche il quarto d’ora di lettura che giornalmente viene svolto in materie diverse: ogni studente, nel momento fissato, si dedica alla lettura del libro che si è liberamente scelto.
Conclusione?
Il discorso sul nuovo progetto didattico è stato ampio e a tratti forse pedante, ma si spera di aver sviscerato bene le questioni fondamentali. Molto, ancora, si potrebbe dire, in merito a tante altre buone pratiche costantemente riprese durante le attività in classe (l’importanza delle valutazioni formative, il ricorso all’occorrenza all’autovalutazione, la creazione di spazi per la libera scelta di “contenuti” e compiti da parte dello studente, l’allenamento graduale alla crezione di mappe concettuali sempre più appropriate, la formazione digitale costante a fronte delle richieste sempre più importanti della società, i momenti al termine di ogni modulo in cui gli studenti valutano l’unità di apprendimento e il lavoro dei loro docenti, e tanto altro ancora). Non si pretende di aver trovato una formula magica per trasformare tutti gli studenti in alunni di successo né di aver risolto le perplessità di chi è meno propenso alle innovazioni nella didattica, ma si crede di aver indicato una strada percorribile per una scuola che sia più autentica, ovvero che si rapporti con più responsabilità ai ragazzi di oggi.
Questo è, almeno, quanto mi sembra – in più di cinque lustri di lavoro – di aver imparato, insegnando.
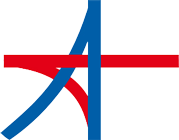
 gratuito, da Pexels.com
gratuito, da Pexels.com

 Teresa Palombini
Teresa Palombini gratuito da pexels.com
gratuito da pexels.com gratuito, da pexels.com
gratuito, da pexels.com gratuito da pexels.com
gratuito da pexels.com


 libero, da Pexels.com
libero, da Pexels.com Gratuito. Da Pexels.com
Gratuito. Da Pexels.com
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!