Giovanni Giudici (1)
Recita a soggetto. Appunti su Giovanni Giudici (1 di 3)
La vita in versi [1], come risaputo, è il titolo programmatico della raccolta con la quale Giovanni Giudici era riuscito dopo le prime prove poetiche a ritagliarsi una propria riconoscibile fisionomia letteraria, a metà degli anni Sessanta, quando s’imponevano neoavanguardia da una parte ed esperienze alternative all’apice della maturità (Luzi con Nel magma e Sereni con Gli strumenti umani) dall’altra, tanto che ancora oggi rimbalza di presentazione in presentazione per introdurre a quella sorta di alter ego un po’ fantozziano messo sulla scena poetica dall’autore: un impiegato alle prese con tutte le difficoltà economiche che mettono a repentaglio il decoro sociale, animato da qualche velleità di ribellione immediatamente frustrata, vittima di complessi e sensi di colpa che gli derivano anche dalla giovanile e un po’ bigotta educazione cattolica ricevuta in collegio, desideroso di trasferirsi in campagna ma attratto dalle comodità che la città gli offre, tentato dalla sublime avventura della poesia ma radicato in un ruolo di adesione al destino delle classi subalterne, improvvisamente animato da fantasie erotiche e regressioni infantili, e così via. Ma, a ben vedere, adattandosi alla sigla del suo primo libro importante, si rischia di lasciarsi guidare da un fantasma di poetica tanto evidente ed emblematico da risultare in qualche modo addirittura prevaricante rispetto alle effettive prove testuali.
Dietro la volontà di costruire un moderno canzoniere, la fantasia creativa si agita infatti in una dialettica, tra vita e versi appunto, che non soltanto non risulta, a quella altezza, ancora risolta, ma che forse non è andata componendosi in una quieta sintesi nemmeno in seguito. Puntualizzare tale dato appare fondamentale per cogliere quegli aspetti stilistici, a tratti persino espressionistici, che rendono giustizia circa la supposta cifra neocrepuscolare che risulterebbe subito qualificante del peculiare timbro espressivo dell’autore: mettere la vita in versi è insomma un dramma tutto da realizzare, anche nei suoi aspetti “sociali”, non un’intimistica opzione acquisita in partenza. Va comunque notato, per inciso, che l’indicazione fortiniana circa la capacità di Giudici di riprendere il discorso poetico lì dove lo aveva interrotto Gozzano resta per molti aspetti del tutto pertinente, laddove non si riduce lo stesso Gozzano alla maniera crepuscolare e s’intenda l’elemento evolutivo, non epigonistico, che mi sembra fosse nello spirito dell’indicazione [2]. E si noti poi, sempre nei confronti del titolo, la scelta lessicale che prevede indicati i «versi» e non la «poesia», opzione che sarà certamente dovuta a contingenze di scrittura, ma che pure fissa il tenore antilirico di Giudici, tenore caratteristico di un modo di rapportarsi alla prosa, al fine di riconquistare posizioni di dicibilità nei confronti del reale, comune in quel particolare frangente all’autore-tipo dell’epoca, sempre più engagé.
Ma, dicevamo, la trasposizione letteraria della propria biografia e con essa della propria condizione storica, sottende in Giudici un rapporto ambivalente con la materia – linguistica e psicologica – da trattare, che contrappone simulazione e verità in un gioco di rispecchiamento fra diversi registri, l’ironico e il tragico, il comico e il sublime, originando una disposizione verso il segno che da affabile nonchalance potrà infiammarsi fino al vero e proprio corpo a corpo con la lingua e le istituzioni letterarie.
La vita in versi è in effetti un libro riassuntivo, che riprende quanto si poteva ritenere soddisfacente – non senza la supervisione di Sereni allora alla Mondadori – fra i testi editi nelle quattro raccolte precedenti [3]. Anche per questa natura composita si possono riscontrare diverse opzioni. Anzitutto, risulta ancora determinante l’influenza di Montale, per un certo scetticismo che presuppone la certezza del male di vivere, per la propensione alle elencazioni e alle sentenze gnomiche, per l’equilibrio fra rispetto delle strutture metriche canoniche e sprezzatura – oltre che, naturalmente, per precise scelte lessicali e il tono complessivo di molti testi:
. È aperta
la chiesa solo il sabato al tardivo
penitente;
già spenta, quando appare, la cometa;
non muta in gloria un tradimento; il cielo
non si traduce in dimensione alterna
a questa che si logora in chi cerca
nel cemento una crepa, lo spiraglio
nel carcere, il cammino sotterraneo
nella fortezza assediata. Al tramonto
il sole non si ferma, e forse il poco
tempo che basta era al di là:
. «[…] È questo
il campo che ho prescelto e tra le sponde
straniere vado e vengo, portatore
delle parole d’ordine; trattengo
fra due maschere avverse un volto solo,
indifferente a come mi sorprenda
l’esito, in fuga o nell’azzurra tenda
d’un vincitore provvisorio.
. C’è
chi mi crede un mercante intento ai traffici:
tu sai soltanto che è ambiguo il mio cuore,
ma non mente. Resistere è difficile»
(L’intelligenza col nemico)
Eppure si avverte in Giudici, nella sua ricerca di un’intelligenza col nemico, un presupposto ideologico non meno controverso di quello di Montale, ma più propositivo, che rovescia la remissività certo sofferta di chi, all’opposto, può già volgersi a se stesso e riconoscersi nelle minime (negative) certezze che stanno a fondamento di un lume che non è «di chiesa o d’officina / che alimenti / chierico rosso, o nero» [4]. In Giudici si tratta invece di resistere nel trovare la mediazione proprio fra cattolicesimo e comunismo, e allora è possibile, nell’atto di far corrispondere al “varco” questo punto di coincidenza, intuire come l’influsso di Montale (che ha dato il via anche per Giudici a un’ipotesi di “linea ligure” a lungo percorsa) sia stato in qualche modo salutare, rappresentando una sorta di inibizione nei confronti di slanci ideologici del tutto impossibili a una poesia che non vuole sottostare alla retorica, bensì dominarla.
Dunque, alla dialettica a livello poetico fra vita e versi si aggiunge quella culturale fra le «due chiese» («E di qua mi respingono, di là non mi vogliono […] e soffoco di veleno, in questo vicolo cieco. / E di orgoglio»), che pure concorre a definire quell’atteggiamento di ricerca, e si dica anche – sulla scorta del primo titolo della raccolta – sperimentale, che consiste nella pratica del dubbio, senza però fossilizzarsi in essa. Ciò permette di allargare il campo a passaggi da vero e proprio esistenzialismo cristiano, in versi, come quelli di Lasciando un luogo di residenza, che sembrano ricalcare le tracce dell’epopea della speranza tipicamente luziana:
Né odio né amore ci lega a questa casa
che speravamo provvisoria (ma
non per un tempo così breve), a questa
casa che abbiamo per primi abitata
e non ha odori che non siano i nostri
di animali docili ed innocui.
Abbiamo in questa ultima domenica
sentito la messa vespertina
nella chiesa di legno, domandato
se era stato completo il nostro obolo
per la chiesa che è da costruire
di calce e pietre – quella che vedrà
gente diversa nascere e morire.
Sono già lontani i nostri figli,
soltanto tua è la voce che mi parla:
mio padre se n’è andato ed è un’età
la sua che ben può dire se sia stata
l’ultima volta che ha visto la città.
Ho deciso in tre giorni di lasciarla
All’interno di una visione certamente più corale, questa consonanza con il percorso poetico di Luzi conferma come sia proprio un fermento cristiano a smuovere la vicissitudine umana, superando l’impasse montaliana, la sua gnosi negativa che salva soltanto l’ipotesi mitica di un varco, senza effettivamente perseguirla.
Ma qui interessa cogliere l’oscillazione a livello di impostazione del discorso. Giudici si muove ancora, sperimentando diverse soluzioni, su cardini solo apparentemente equivalenti. Seguendo una linea astratta che prevede il rovesciamento del primo elemento alla base della dialettica giudiciana (la vita, il cattolicesimo) sul secondo (i versi, il comunismo), si riscontrano infatti testi che cercano quasi una diretta trascrizione autobiografica; scatti epigrammatici sull’asse di un discorso fra il poeta e il suo interlocutore; momenti autobiografici che, trasposti in versi, assurgono a quadri metafisici di una condizione in cui il soggetto si rende disponibile a una vicenda universale; composizioni che cercano un correlativo oggettivo al discorso poetico, lasciando retrocedere la figura dell’autore al limite di una sua scomparsa; invenzione di personaggi tipici dallo spiccato taglio sociologico di marca lukacsiana; creazione, infine, di un io-personaggio, secondo gli esiti più tipici e alti di questa fase della poesia di Giudici.
Va da sé che la distinzione di queste coordinate si attua all’interno di un processo di astrazione e sarebbe opportuno svilupparle organicamente nella loro fenomenologica coesistenza, come per esempio avviene in modo paradigmatico nella poesia Il ventre della lucertola. Qui, dopo un verso apodittico e isolato («Per non bruciare l’uomo deve scegliere»), che ancora una volta può essere strumentalizzato per rovesciare una proposizione montaliana («Bene lo so: bruciare / questo, non altro, è il mio significato» [5]) ripristinando il valore dinamico del contrasto altrimenti fissato in un “delirio d’immobilità”, la poesia assume la lucertola come metafora della condizione che vuole esprimere, in un correlativo oggettivo ancora montalianamente imperfetto, dal momento che subito si innesta nell’immagine il momento assertivo che spiega l’immagine stessa [6]: « – l’uomo / dove proteggerà le sue gementi / fibre quando saranno nude?». Da questo punto in avanti, infatti, si assiste a una impennata raziocinante e visionaria al contempo, barocca e biblica:
Salta
il ladro fuggitivo sul cancello
di punte alabardate, in mezzo al filo
spinato s’impiglia l’agnello
deliberato a perdersi, sull’alta
resinosa s’aggrappa un altro quando
l’assedia il fuoco alle radici e osando
volgersi indietro l’inseguito asilo
cerca sul passo che lo fa tremare,
volendo qualche volta per durare
vivo al mondo non vivere
che subito si ricuce a un’introflessione esistenziale: «Da molto a un sordido riparo anch’io m’aspetto / di finire, in silenzio per paura / di muovermi…», che poco oltre offre l’occasione all’interlocutore ideale di profilarsi nel testo: «Arrivano: non chiedere perché / ho diviso tra noi le vostre sorti». In modo analogo, in Versi per un interlocutore, l’«uomo di doppia verità», evidente alter ego dell’autore, che campeggia nel testo è motivo di riflessione fra il poeta e, appunto, il destinatario dei suoi versi
Vive, un uomo di doppia verità
alla periferia di Budapest la casa
nuova di György Lukács oggi è invasa
ancora (tu mi spieghi) dal silenzio.
[…]
Gli errori del popolo non sa
chi in se stesso non li ha patiti e crede
palese il vero e vero ciò che vede
in altri, tutti gli uomini in eguali
numeri imprigionati, i loro mali
senza volto, i peccati senza amore.
Chiuso nel suo logico splendore
che non risplende, non potrà mai più
credere ciò ch’è assurdo: se Gesù
non è risorto la tua fede è vana
anch’essa e perduto il tuo sforzo a un’umana
virtù.
Dietro il motto di Tertulliano, Credo quia absurdum, è malcelato un sentimento di orgoglioso “populismo”, di sincerità umana che rifugge da un rapporto intellettualistico nella ricerca della verità.
A ogni modo, si potrebbe addurre come esempio di una vena autobiografica una poesia esplicita come Dal cuore del miracolo («Parlo di me, dal cuore del miracolo: / […] Già piegato, presumo di non cedere), che ci riconduce al contesto sociale (la crescita economica del Paese) cui il poeta presta sempre attenzione. Certo c’è da ribadire il fatto che per Giudici non ha senso parlare di autobiografismo da intendersi come tensione lirica, come espressione di sé compressa nelle vertigini del sentimento individuale, non mancano però in tutta l’opera tracce disseminate in cui l’esperienza personale filtra in presa diretta nel racconto poetico. Del resto, tutta la sezione L’educazione cattolica corre sul filo di un recupero di vicende e figure del passato, sebbene agglutinate in distinti frammenti che si propongono come fugaci apparizioni sul teatrino della memoria, lasciando al gesto e alla battuta il compito di rappresentare i motivi lirici.
Il discorso poetico si presta invece a una marcata sentenziosità quando presuppone un interlocutore. Si tratta, evidentemente, di un “tu” ancora molto montaliano, lungo un asse di rapporto con l’alterità che può svilupparsi anche al plurale, come per esempio nella poesia I vecchi («Non onorate i vecchi, / abbiatene pietà»). La strategia comunicativa è particolarmente idonea per veicolare contenuti ideologici, come per esempio avviene in Mi chiedi cosa vuol dire, dove si fornisce all’interlocutore (in questo caso Franco Fortini) la propria spiegazione della parola «alienazione», ma anche a divertite rivisitazioni letterarie che desublimano la donna, spostando l’intonazione su registri “comico-realistici” come avviene nella graziosa Tanto giovane:
«Tanto giovane e tanto puttana»:
ciài la nomina e forse non è
colpa tua – è la maglia di lana
nera e stretta che sparla di te.
E la bocca ride agra:
ma come ti morde il cuore
sa chi t’ha vista magra
farti le trecce per fare l’amore.
Il rovesciamento anti-stilnovistico marca, pur all’interno del nesso privilegiato fra poeta e seconda persona, una sostanziale differenza in Giudici: la tendenza cioè a non idealizzare tale punto di fuga, a non creare, come avviene in Montale, una metafisica semplice. La frequente riconoscibilità dell’interlocutore è spesso la garanzia di tale resistenza, anche se spesso l’esito è ancora l’immobilità dell’attesa: «Non mi credi? / Attesta / la mia parola la disubbidienza / civile, la protesta / del tuo popolo: punto sulla terra / i piedi, alzo la testa / benché mi pesi – ad aspettarti. // Ma lo spazio d’una vita non basta / a rivelarti» (Versi in una domenica di Pentecoste e di elezioni).
I conti con Montale non sono ancora chiusi. Lo dimostrano anche i passaggi, metafisici si direbbe, in cui l’indagine esistenziale offre carne e sangue a una vicenda universale, che tuttavia risulta ancora conchiusa, come se si stesse costruendo una specie di immaginario poetico tutto giocato dalle sue scelte primarie, un mondo dominato da un ineludibile benché occulto determinismo. Così è nella angosciosa L’incursione sulla caserma («Ero immobile sotto un calmo cielo, / marzo pieno d’azzurro, ma quel cielo / non potevo vedere contro il nero / asfalto in cui premevo la mia faccia»), o nelle due quartine rimate di Quando piega al termine, in una sequenza di testi che per formalizzazione, tono e visioni ricordano davvero da vicino gli “ossi” o i “mottetti” del più celebre poeta ligure. Ma anche quando le misure si dilatano e la vena narrativa trabocca, seguendo un flusso quasi onirico, i toni sereniani tradiscono la comune matrice. Si veda Port-Royal, da accostare alle apparizioni che chiudono gli Strumenti umani.
L’orientamento complessivo è comunque chiaramente volto verso la creazione di figure umane che rispondano al progetto di mettere in versi la vita. Quando tali figure risulteranno paradigmatiche e nel contempo non motivate da un nesso biografico evidente o intuibile, si potrà forse parlare di potenziali correlativi oggettivi, come nella Caduta del ciclista, sebbene l’interferenza riflessiva e la forza plastica dell’immedesimazione lascino incompiuta tale soluzione: «capovolgersi è un attimo, la mia // stessa vita precipita con lui / la fronte a quel durissimo cemento, / si spaccano i suoi denti in me, mio sangue // è il sangue tra i suoi capelli, il lamento // degli ossi fratturati che già fui».
Piuttosto, la via congeniale viene offerta a Giudici proprio dalle teorie letterarie elaborate dalle ideologie marxiste cui egli guarda con attenzione. Spicca, infatti, in molti dei suoi versi, un taglio sociologico alla ricerca del “tipo”, non estranea alla propensione nominalistica di una poesia che vuole, invece di selezionare liricamente il poetico, aprire i versi alla totalità della dimensione umana, predisposta a una verve di impegno anche ideologico: «casa, ragazza, annosa / mignotta, spietato trafficante, / verme dai conti in regola, compagno, ruffiano, / vecchio maestro, prete, nazista, americano, / politico dai nobili sdegni, disfatto padre». Ecco allora riemergere dalla memoria la felliniana «giovane sovietica» di un ballo, oppure, direttamente dalla cronaca, un calciatore si presta addirittura per fare della sociologia (Viani, sociologia del calcio), così come un lui e una lei mettono in scena la desolazione di un Amore rivisitato, o un gruppetto di impiegati al cospetto di «un signore vestito di nero» riproducono meschinamente in forme socialmente corrette La persecuzione razziale. O, ancora, l’impiegato invitato a Cambiare ditta, ombra dello stesso Giudici, che si adagia supinamente al suo destino come si adeguerà linguisticamente alla formula più banale per annunciare ai lontani la novità: «Questa mia è per dirti che adesso mi trovo…», o quel «Trotski lattaio in maglia di flanella» che per essere diventato fascista si troverà a espiare la virtù di una vita, per un solo peccato mortale, «con infamia e vergogna», o ancora «l’ufficiale giudiziario» sorpreso in un bordello – e il lettore continui da sé la galleria di personaggi.
Su tutti, però, spicca per resa poetica e ampiezza di rappresentazione quella sorta di io-personaggio che tutte queste soluzioni sembra portare a sintesi, riuscendo a convogliare su un’unica figura tutte le tematiche e tutte le soluzioni fin qui rapidamente indicate. La novità di questa trasposizione in versi del proprio io sta appunto nell’equilibrio, o meglio ancora nella sospensione che si riesce a creare tra sincerità e finzione. Se risulta evidente che tale personaggio rappresenta lo stesso autore, proprio la resa stilistica e figurativa lo traspone già in figura letteraria indipendente. Non c’è idealizzazione nel trattamento della materia biografica, o almeno tale idealizzazione si rovescia spesso per via ironica, come se il personaggio che si viene a creare godesse a tutti gli effetti di una sua autonomia, per forza di coerenza ed emblematicità proprie. Il rapporto tra lo scrittore e il suo corrispettivo poetico è paritario, in un rispecchiamento che non è solo la ricerca di un equivalente sociologico della propria realtà interiore (il particolare che si coniuga all’universale, secondo i dettami di Lukács), ma una figura letteraria a tutto tondo.
Che la ricerca fosse coscientemente indirizzata verso questa soluzione appare chiaro in un testo come Mimesi, che mi sembra cruciale almeno nel punto in cui si prende posizione per una più vera e complessa trasposizione in versi dell’esistenza:
ho specchiato i pensieri della gente:
certo non senza ironia – ma troppo
celata non serve – ho parlato
di ordine col reazionario,
di borsa col possidente,
di calcio col tifoso – e raramente
me stesso ho scoperto com’ero
nella dovuta misura:
l’amaro spino del vero ho temuto
– non l’impostura.
Un tempo di vita ho perduto
a travestirmi a scherzare
sicuro che dietro ogni maschera
l’altro che ero restasse
paziente ad aspettare:
al momento opportuno per essere pronto,
con uno scatto di reni
riemergere dal fondo…
…………
È artrite o artrosi che mi fa torcere il collo?
Ma di chi sono queste parole che dico?
Già forse ho una mia smorfia abituale?
E niente più da nascondere?
Solo me da imitare?
NOTE
[1] Giovanni Giudici, La vita in versi, Milano, Mondadori 1965.
[2] Per quanto riguarda la distinzione fra Gozzano e il movimento crepuscolare si tenga presente anche soltanto l’efficace titolo dell’antologia di Cecilia Ghelli, Gozzano e i crepuscolari (Milano, Garzanti 1983), ma si veda anche il contributo di Giuliano Ladolfi, Guido Gozzano: la morte e il sogno, «Atelier», I, 3, set. 1996, pp. 7-22.
[3] Si tratta delle raccolte Fiorì d’improvviso, Roma, Edizioni del Canzoniere 1953; La Stazione di Pisa, Urbino, Istituto Statale d’Arte 1954; L’intelligenza col nemico, Milano, Scheiwiller 1957; L’educazione cattolica, ivi 1963.
[4] Eugenio Montale, Piccolo testamento, dalla raccolta La bufera e altro, in Tutte le poesie, Milano, Mondadori 1984, p. 275.
[5] Eugenio Montale, Dissipa tu se lo vuoi, sequenza finale di Mediterraneo, dalla raccolta Ossi di Seppia, in Tutte le poesie, cit. p. 61.
[6] È tipico infatti del “primo” Montale, all’altezza degli Ossi di seppia, cogliere emblemi dal paesaggio, contaminando però tale momento descrittivo, come ha annotato Contini, con un momento assertivo (cfr. Gianfranco Contini, Introduzione a ‘Ossi di seppia’, nel volume Una lunga fedeltà. Scritti su Eugenio Montale, Torino, Einaudi 1974); l’occultamento di questo secondo momento sarà alla base dell’evoluzione poetica rappresentata dalle Occasioni, che maturano così la teoria del correlativo oggettivo che ha, come noto, in Eliot l’involontario teorico (e si veda, a proposito, il saggio Amleto e i suoi problemi in Thomas Stearns Eliot, Il bosco sacro. Saggi sulla poesia e la critica, Milano, Bompiani 1985, p. 124).
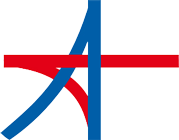












Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!